L'ultima battaglia per la conquista di Roma papalina

Ci avevano detto che a Roma nel 1870 il Papa-Re Pio IX, prima di lasciarsi invadere dall'esercito italiano aveva ordinato, di fare soltanto una difesa simbolica. Invece non è proprio così, l'ho “scoperto”, leggendo il documentato volume del giornalista Antonio Di Pierro, «L'ultimo giorno del Papa Re. 20 settembre 1870: la breccia di Porta Pia», Mondadori (2007). Altro che difesa simbolica, quel martedì mattino del 20 settembre 1870 a Roma, si è combattuta una vera e propria battaglia tra i pontifici e l'esercito regio di Vittorio Emanuele.
Vediamo di entrare dentro al testo del giornalista romano. Roma è circondata da cinque divisioni militari, formata da 50 mila soldati italiani. Mentre la città del Papa Pio IX difesa da 11 mila uomini in armi, pronta a resistere. Ed effettivamente hanno resistito per ben 5 ore, dalle 5,05 fino alle 10,10, quando si è aperta la breccia a Porta Pia.
Il libro nonostante le 326 pagine, note comprese, fa una cronaca dettagliata, ora per ora e in presa diretta, della giornata cruciale per i destini dell'Italia e della Chiesa cattolica. E per seguire questa cronaca il testo offre, sia nella prima che nell'ultima pagina una pianta di Roma, dove si possono individuare i movimenti delle truppe dell'esercito italiano. Inoltre alla fine del libro c'è una guida ai «principali luoghi della Breccia», ma per seguire i momenti, i vari spostamenti delle truppe; però serviva una cartina topografica della città e forse anche una buona dose di cultura militare.
Il testo di Di Pierro, è scritto con una coniugazione dei verbi al presente, è come se chi scrive è testimone diretto di quanto sta accadendo. «E questo contribuisce a ricostruire meglio il mosaico degli avvenimenti anche minuti, lo stato d'animo degli assediati e degli assedianti, il travaglio del papa attaccato così duramente da un re cattolico (Vittorio Emanuele II), il disincanto dei romani, il terrore della nobiltà nera chiusa nei suoi lussuosi palazzi, la gioia dei patrioti che vedevano coronare il sogno vagheggiato da Cavour, da Garibaldi, da Mazzini e dai tanti protagonisti del Risorgimento italiano».
Tuttavia anche per scrivere questo libro, il metodo è sempre lo stesso, utilizzare le fonti negli archivi e nelle biblioteche e così pare che abbia fatto Di Pierro, vista la bibliografia finale pubblicata.
La conquista di Roma, che stanno facendo le truppe italiane, è una strana guerra non dichiarata, un esito che sembrerebbe scontato, viste le forze in campo. La prima ed unica guerra che finora l'ex Regno di Sardegna ha combattuto è stata quattro anni fa a Custoza e l'ha persa pesantemente. Tra l'altro negli anni precedenti, l'esercito piemontese non aveva dato prove esaltanti.
Ce la farà adesso contro il debole Stato Pontificio a conquistare Roma? Pare di sì. Secondo il ministro Visconti Venosta, probabilmente nessuna potenza sarebbe scesa in campo per difendere il papa. Tuttavia come scrive Di Pierro questa guerra, «doveva essere morbida, non doveva dare occasioni alla comunità cattolica – più di quante non ne offra di per sé un attacco armato al capo supremo della Chiesa – di montare uno scandalo internazionale». Ecco perché Raffaele Cadorna, il comandante generale, quello che non ha esitato di bombardare Palermo nella rivolta del “Settemezzo”, era contrario alla partecipazione alla guerra della “testa calda” di Nino Bixio, nel frattempo diventato generale dell'esercito sabaudo.
Tutto è pronto per la battaglia, l'esercito del Re Vittorio è schierato per l'attacco, tutte le porte di Roma, da quella del Popolo a San Giovanni è ormai interamente presidiato dall'esercito italiano. Occupate anche villa Borghese e villa Albani. L'artiglieria è pronta. I cannoni sono puntati contro Roma in attesa dell'ordine dell'attacco. Ma paradossalmente «i primi a far parlare le armi sono i pontifici. E la prima vittima della giornata è un artigliere italiano, il caporale Michele Plazzoli». Peraltro dalla “cronaca”, del giorno prima si apprende che nei pressi di porta Maggiore, c'è stata battaglia, con morti e feriti, addirittura i pontifici hanno fatto anche un prigioniero, il fante Giuseppe Spagnolo.
Di Pierro riporta la notizia di un altro prigioniero, un giovane ufficiale dell'esercito sabaudo, che il Papa in persona ha ordinato di liberare, motivando la liberazione con delle curiose parole: «Per isbaglio quel giovane ufficiale è entrato in Roma, ingannato dai suoi sensi, dal suo orientamento; egli è l'immagine del governo italiano[...]».
Pertanto Di Pierro può scrivere: «Chi prevedeva una resistenza puramente simbolica dell'esercito di Pio IX ora comincia a ricredersi. E a mettere in dubbio che il proposito del pontefice – come qualcuno sostiene – sia di arrendersi presto, giusto il tempo di certificare di fronte alle diplomazie europee che la santa Sede è vittima di un'aggressione militare e cede solo per evitare un inutile bagno di sangue[...]». Doveva essere così ma la battaglia provocata dagli zuavi ai Tre Archi e a Villa Patrizi, «farebbero pensare a un esercito che vuole combattere e resistere il più a lungo possibile».
Infatti secondo Di Pierro, riferendosi al comandante generale Hermann Kanzler «il vero sogno del pro-ministro pontificio, che nel 1867 aveva sconfitto Garibaldi a Mentana, era quello di coprirsi di gloria piegando in campo aperto l'odiato Bixio [...]». Praticamente Kanzler voleva combattere, non ci sta a fare una resistenza simbolica, aveva provato ad esporre la sua strategia al Pontefice, che avrebbe troncato la discussione esclamando: «Vi chiediamo di cedere, non di morire, che è quanto dire un sacrificio maggiore».
Ritorniamo alla battaglia, poco prima delle 5,10, la fucileria papalina ha rotto la quiete del mattino. «Diverso era il piano d'azione degli italiani, che, colti di sorpresa, in un primo momento nemmeno hanno risposto ai tiri nemici». I primi a sparare sono stati gli zuavi della squadra comandata dal tenente Paolo Van de Kerkhove. Seguo quello che scrive Di Pierro: «un vero e proprio inferno di fuoco si è abbattuto sulla 5a batteria causando subito gravi perdite». Ci sono morti e feriti, il giornalista fa i nomi.
«Tra i soldati del re è il caos». Ma alle 5,15, iniziano le cannonate da parte della 13a Divisione del generale Ferrero. «E, in rapida successione, lungo quasi tutto il fronte delle mura Aureliane, entrano in azione le micidiali artiglierie dei due fronti contrapposti tra nuvole di fumo, boati da far tremare, proiettili e granate che volano da una parte all'altra portando morte e distruzione». A questo proposito sono interessanti le riflessioni del dottore Alessandro Ceccarelli, capo del servizio chirurgico del Santo Spirito, che segnala le capacità distruttive delle armi negli ultimi anni. L'arte della guerra è cambiata, così sono terribili gli strumenti di cui essa si serve. Interessante e raccapricciante la descrizione che fa il dottore sulle fratture, sulle ferite che provocano i nuovi proiettili. E ancora il dottore non aveva conosciuto l'evoluzione delle armi nella prima guerra mondiale.
In pratica in successione nel testo Di Pierro, passo dopo passo riporta i vari passaggi della battaglia. Le incursioni, gli spostamenti, gli assalti, i ripiegamenti e soprattutto la gran massa di fuoco che converge sui grossi muri, tra le varie porte, soprattutto quella di Pia e Salara, dove sono concentrati 52 cannoni dell'esercito regio.
I fronti della battaglia sono tanti, si spara dappertutto, sul versante destro del Tevere e quello sinistro.
Mentre si combatte il Papa Pio IX è nel suo studio. Le cannonate fanno tremare non solo i vetri, ma le pareti, il pavimento, la sua scrivania. Il libro descrive con molta precisione tutta la macchina burocratica vaticana, le stanze, gli uffici, i nomi dei prelati che si trovano vicino al papa. «Le stanze e i punti strategici dei palazzi vaticani brulicano inoltre di soldati e ufficiali che per compito istituzionale sono destinati alla difesa della persona del pontefice e alla rappresentanza d'onore, suddivisi in tre corpi speciali: la guardia nobile, la guardia palatina e la guardia svizzera».
Questi corpi speciali erano disposti a tutto, sorvegliavano i punti strategici anche se non avevano ricevuto ordini precisi sul da farsi in caso di assedio della cittadella del Papa. Intanto mentre infuria la battaglia, sotto le cannonate, alle ore 7,15, il papa celebra la Messa, alla presenza del corpo diplomatico, in una atmosfera surreale.
La guerra continua e lascia sul terreno altri morti, altri feriti. Lo scontro ha acquistato maggiore intensità su tutti i fronti. Ma il fronte principale è a porta Pia, è qui che si giocano le sorti della guerra, il futuro dello Stato Pontificio, il destino di Pio IX e del suo governo. Verso le 8 per una falsa notizia i pontifici cominciano a ritirarsi, ma una volta compreso l'errore, riprendono le posizioni.
Lo scontro si fa sempre più aspro, c'è da registrare che nonostante i combattimenti, nelle strade ci sono curiosi, amici, parenti dei combattenti. Può capitare che le donne cercano i mariti che stanno combattendo, soprattutto quelli di parte pontificia.
Il papa finito di celebrare la Messa, parla al corpo diplomatico, sono in 17, impettiti nelle loro uniformi d'alta rappresentanza. Il Papa è amareggiato. Nessuno è sceso in campo per difenderlo, nemmeno le grandi famiglie, delusione nei confronti dei romani assediati. Rivolgendosi agli aggressori dice: «Non è il fiore della società che accompagna gli italiani quando assale il padre dei cattolici».
Alle 9,05 i vertici militari pontifici, valutando con molto realismo che ogni ulteriore resistenza sarebbe vana, decidono per la resa immediata. Si ordina di mostrare la bandiera bianca su S. Pietro. Ma alle 10 si combatte ancora. Gli zuavi hanno grande voglia di combattere, o almeno di rinviare il più possibile il momento umiliante della resa.
Fermare la macchina della guerra non è semplice, fare arrivare a tutti l'ordine di resa non è semplice. Alcune postazioni in questi momenti drammatici non trovano neanche una bandiera bianca, ci si affanna a trovare qualcosa che assomigli.
Alle ore 10,10, il primo militare dell'esercito regio, il sottotenente Federico Cocito del 12° Battaglione bersaglieri, raggiunge il ciglio della breccia della porta. Mentre verso porta Maggiore, l'ultimo ad arrendersi è il maggiore Castella e siamo alle 10,55.
Alle truppe zuave non rimane che ritirarsi in Vaticano, per evitare di cadere prigionieri degli italiani. «I soldati sono stanchi, molti di loro covano rancore per la bruciante sconfitta, quasi tutti nutrono sentimenti di disprezzo nei confronti del popolo romano che non ha mosso un dito per difendere il Santo Padre dall'ingiustificato attacco nemico». Per la verità per certi versi neanche l'esercito regio ha simpatia per il popolo romano, capita che qualche ufficiale, rimproveri certi scalmanati che inveiscono contro inermi soldati pontifici. “dovevate reagire prima contro i papalini, non ora, che c'è la copertura dell'esercito italiano”.
Comunque sia per Di Pierro, la Roma papalina ha deluso i soldati italiani, che si aspettavano una città diversa. «Ai militari dell'esercito regio arrivati fin qui ancora non è apparso nulla della tanto decantata maestosità della città eterna: piuttosto hanno sentito una diffusa puzza di cavolo bollito, predominante su altri e variegati cattivi odori, e hanno potuto constatare con i propri occhi che la sporcizia è veramente tanta ed è disseminata dappertutto».
A questo Di Pierro non fa che citare alcuni celebri viaggiatori che emettono dei giudizi su Roma abbastanza negativi. Il testo descrive dettagliatamente la vita sociale dei romani, dei ceti popolari, in particolare il loro sistema abitativo. Il francese, Paul Desmarie, definisce Roma: la patria dei mendicanti. E qui la storia si ripete, sembra Macron oggi.
Dal XII capitolo il testo fa la cronaca delle trattative di pace, mentre l'esercito occupa la città, spuntano le prime bandiere tricolori. Il giornalista Ugo Pesci, esiliato, ora entra in città insieme ai soldati, anche Nino Costa, esule, ritornato per guidare un governo provvisorio dei romani. Il testo accenna al caso Mortara, che il fratello Riccardo vuole “liberare” dalla segregazione in Vaticano, ma questi rifiuta la liberazione.
Nascono i primi presìdi rivoluzionari, manifestanti, i cosiddetti patrioti, esuli che ritornano. C'è il rischio di scontri con i papalini. Ad un certo punto Di Pierro si pone la domanda: ma chi è questa gente che se ne va in giro a ingiuriare e ad assaltare i soldati del papa? Non è facile rispondere, per alcuni sono i patrioti romani che hanno subito le angherie dello Stato pontificio, per altri, invece sono agenti al soldo del governo italiano, mestieranti dell'anarchia, gente che viene da fuori.
In questi momenti, come in tutte le guerre, ci sono i regolamenti di conti, e poi quelli che saltano sul carro del vincitore.
Alle ora 14 sembra che ancora la città è fuori controllo, si riscontrano incursioni di gruppi armati, pontifici che improvvisano barricate, sparatorie. La città è ancora in preda all'anarchia. «Nelle zone franche può succedere di tutto: anche che scoppi una vera e propria battaglia. Come per esempio, intorno al Campidoglio».
Intanto a Villa Albani, dove risiede il generale Cadorna, si tratta per le condizioni della resa. Il generale non accetta, nelle condizioni poste dal Papa, la parola “violenza”. Ma alla fine si arriva a una mediazione. Alle ore 17,30, si firma l'intesa. Al Papa rimane il piccolo territorio, della cittadella del Vaticano, il rione Borgo.
I militari pontifici, deposte le armi vengono condotti a Civitavecchia, i 4.800 stranieri instradati ai loro paesi. I 4.500 italiani inviati in diverse località come prigionieri di guerra.
I numeri di questa guerra inutile: 48 morti e 132 feriti tra gli italiani, 20 morti e 49 feriti tra i pontifici. Certo non sono elevati come per altre guerre, ma se il re Vittorio e suoi generali non avessero aggredito un piccolo stato inerme, riconosciuto da tutte le diplomazie del mondo, potevano essere evitati.







.jpeg)




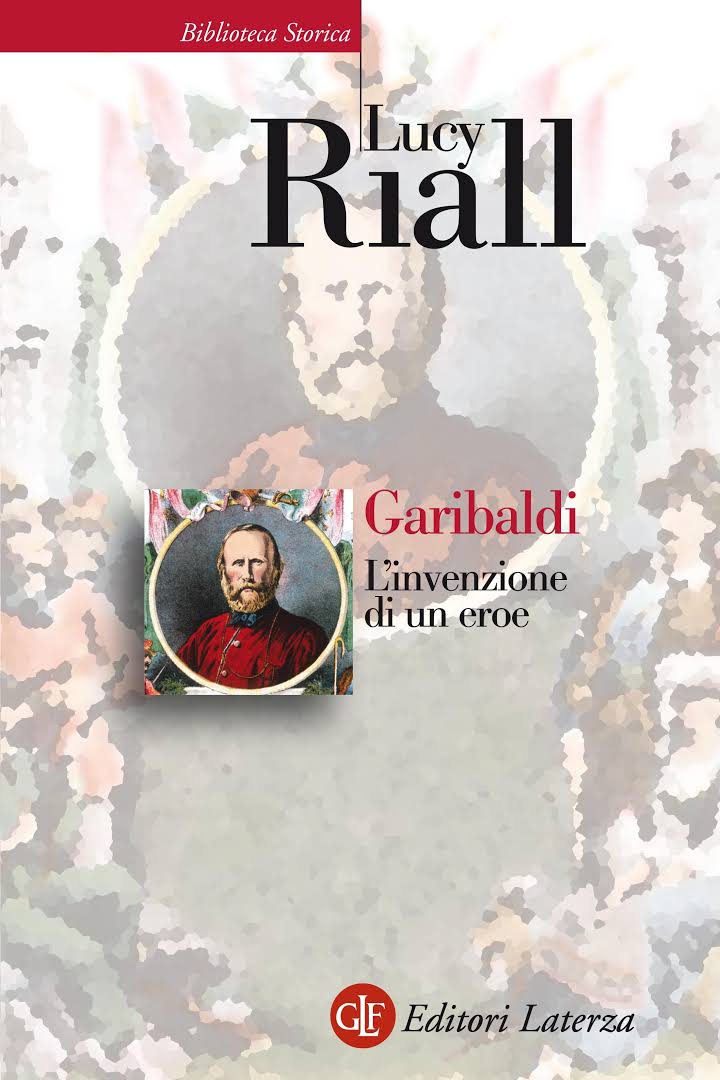



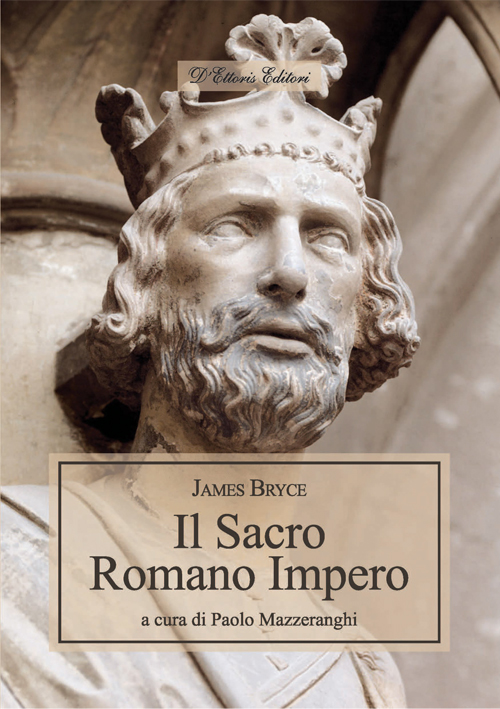




















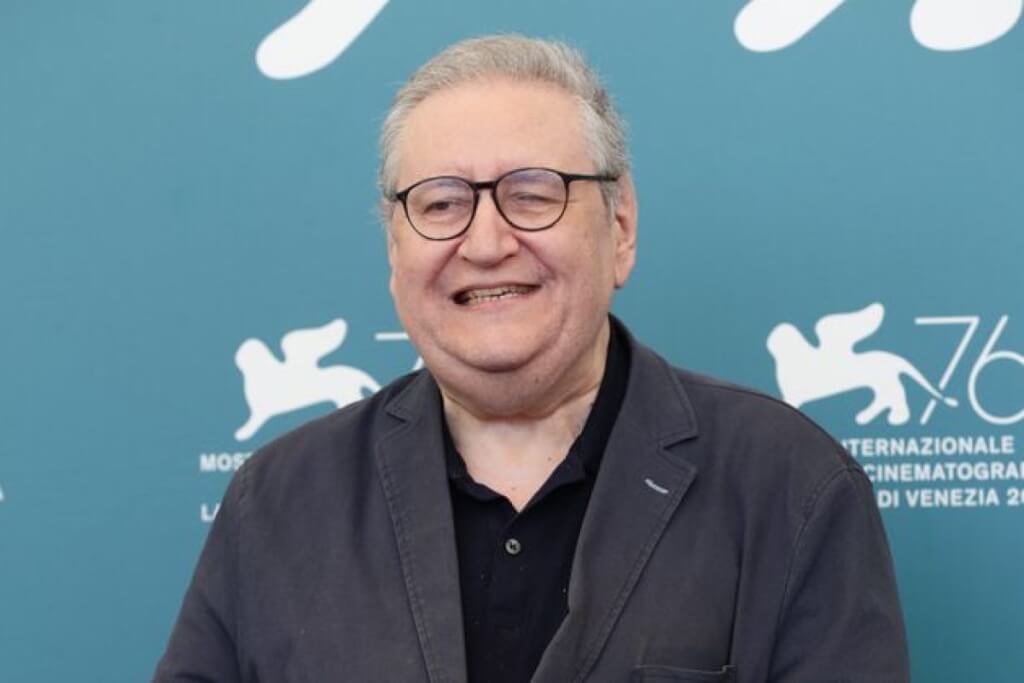



.jpeg)















, Filippo,.jpg)


















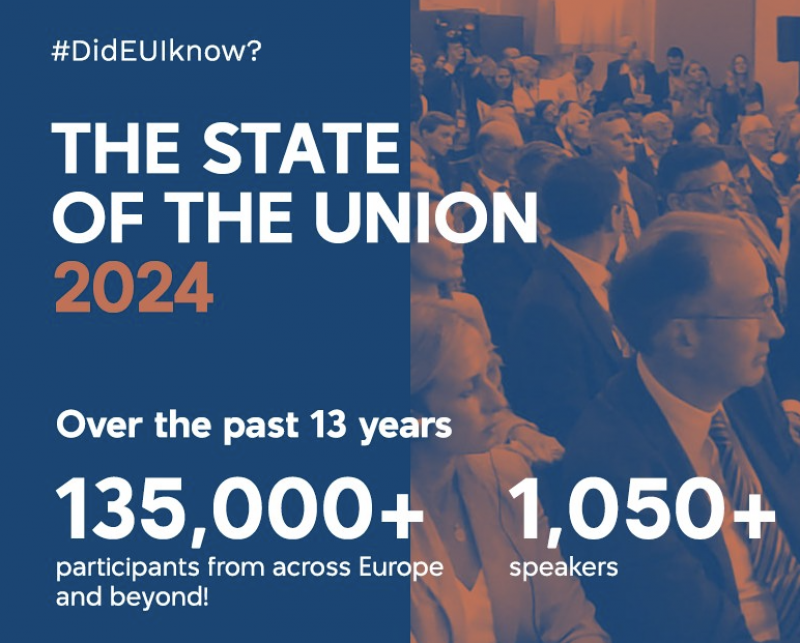

















.jpeg)




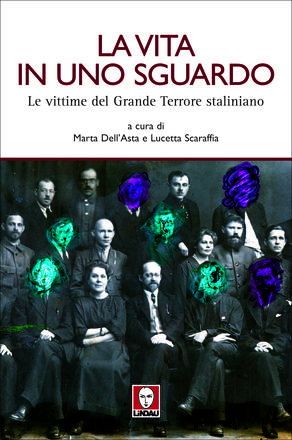
























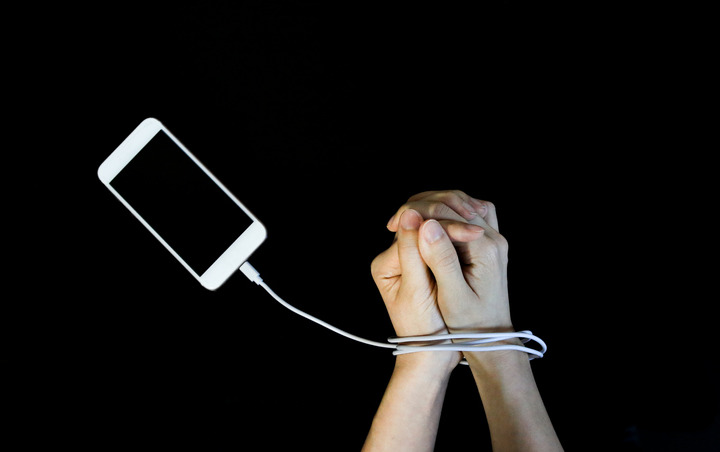
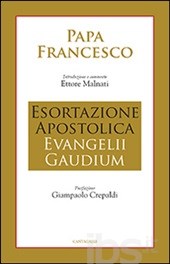





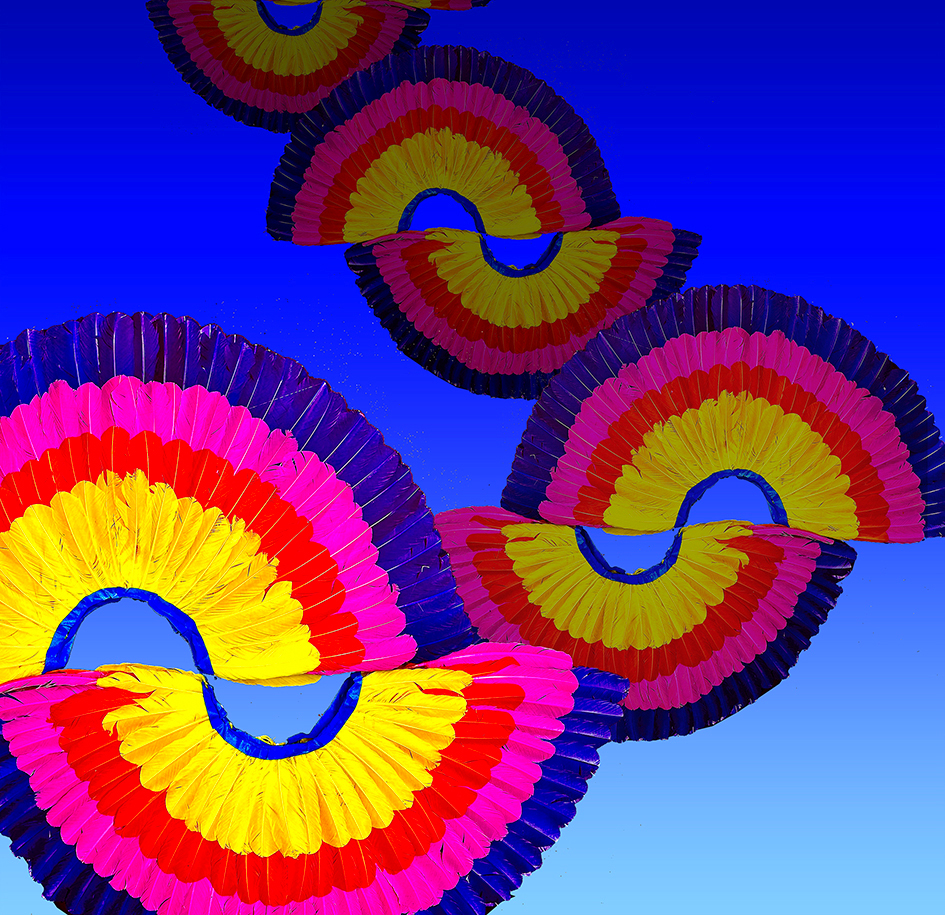












)