Malattie rare: un nuovo farmaco per la pericardite idiopatica ricorrente

Sul The New England Journal of Medicine pubblicati i risultati di uno studio internazionale che documenta l’efficacia del rinolacept. Coinvolti nella sperimentazione l’Università degli studi di Milano, con il Fatebenefratelli Sacco di Milano come centro Promotore in Italia, la Città della Salute e della Scienza di Torino, e il Bambino Gesù di Roma, unico centro pediatrico.
Un nuovo farmaco per il trattamento di una malattia rara autoinfiammatoria che colpisce il cuore, la pericardite idiopatica ricorrente. Sul The New England Journal of Medicine sono stati pubblicati i risultati dello studio internazionale che confermano l’efficacia del rinolacept, sviluppato da Kiniksa. La sperimentazione ha coinvolto diversi centri negli Stati Uniti, in Israele e in Australia. In Italia hanno partecipato la Città della Salute e della Scienza di Torino, l’Ospedale Fatebenefratelli Sacco di Milano e il Bambino Gesù di Roma, unico ospedale pediatrico.
LA MALATTIA
La pericardite idiopatica ricorrente è una malattia rara autoinfiammatoria, di cui non si conosce la causa né la reale incidenza. La malattia è caratterizzata da episodi ricorrenti di infiammazione del pericardio (pericardite), la membrana che riveste il cuore. Gli episodi di pericardite acuta si manifestano con febbre, dolore toracico, astenia (debolezza generale), affanno e difficoltà respiratoria e sono spesso caratterizzati dalla presenza di versamento pericardico, cioè di liquido nel pericardio. Si tratta di una condizione che va valutata tempestivamente. In Italia esiste una associazione di malati molto attiva: il GILP: Gruppo Italiano Lotta alle Pericarditi. Da qualche anno è stato dimostrato come nell’origine della malattia svolga un ruolo chiave una molecola infiammatoria chiamata Interleuchina 1.
LE TERAPIE ESISTENTI
Questa patologia può essere curata con la colchicina e con i farmaci antinfiammatori non steroidei che nel bambino rappresentano la prima scelta poiché hanno minori effetti collaterali rispetto agli antinfiammatori steroidei (cortisone)). Tuttavia spesso tali farmaci non sono sufficienti a prevenire le ricadute e quindi è necessario utilizzare il cortisone, anche per lunghi periodi, con tutti gli effetti collaterali che tale terapia purtroppo comporta nel lungo termine.
LO STUDIO
Lo studio internazionale pubblicato sul The New England Journal of Medicine ha coinvolto 86 pazienti di età superiore ai 12 anni. Si è trattato di uno studio di fase 3, che è l’ultima prima della commercializzazione. Il farmaco utilizzato nella sperimentazione, il rilonacept, è un nuovo inibitore dell'Interleuchina 1. Oltre a essersi dimostrato efficace nel trattare l'episodio acuto di pericardite, è risultato efficace nel prevenire le recidive. Ha consentito inoltre di diminuire rapidamente, fino a eliminare, eventuali terapie concomitanti tra cui il cortisone, con tutti i suoi effetti collaterali. Presenta anche il vantaggio di essere somministrato sottocute una sola volta a settimana. Il suo utilizzo sui pazienti con pericardite idiopatica ricorrente ha consentito e consentirà un netto miglioramento della qualità di vita dei pazienti, con evidente riduzione dei ricoveri ospedalieri e delle complicazioni associate alla malattia.
La ricerca Italiana da anni è all’avanguardia in questo campo, e lo studio pubblicato da un lato permette un approccio mirato e moderno alle pericarditi, dall’altro apre una finestra importante sulla fisiopatologia e farmacologia dei nuovi modelli dell’infiammazione.







.jpeg)











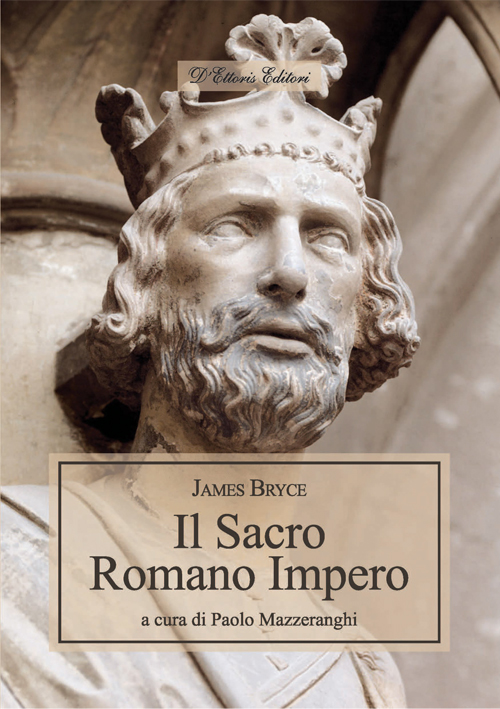




















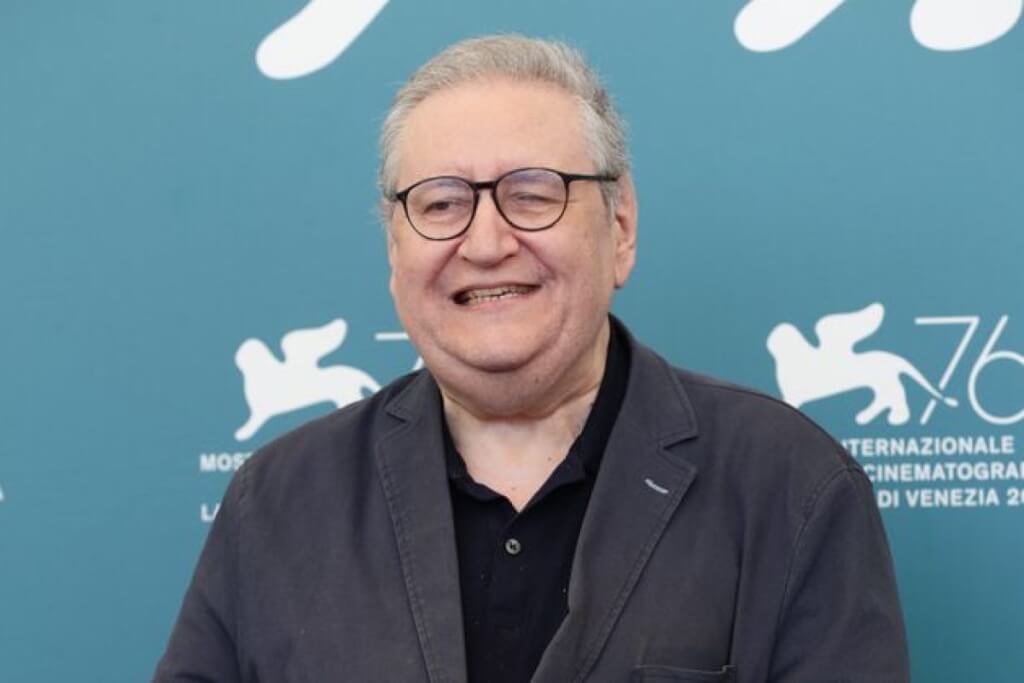



.jpeg)















, Filippo,.jpg)


















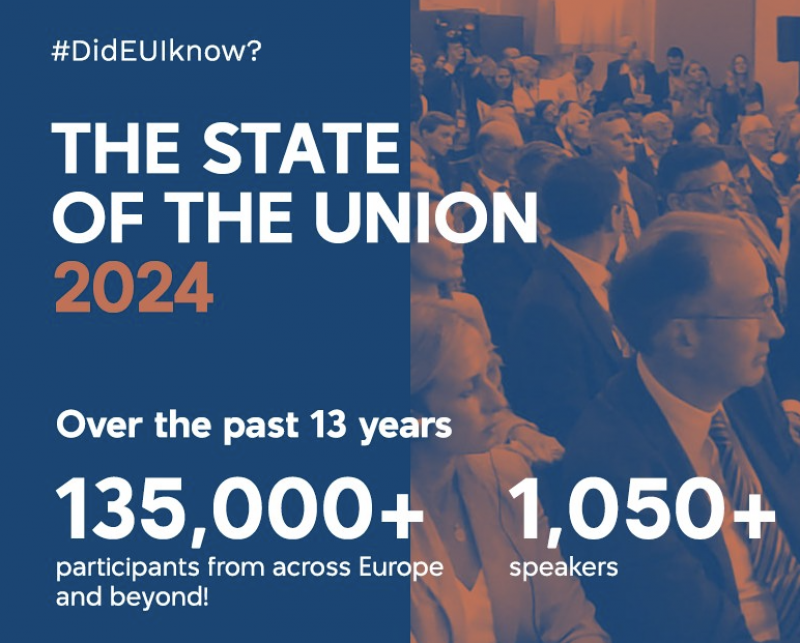






























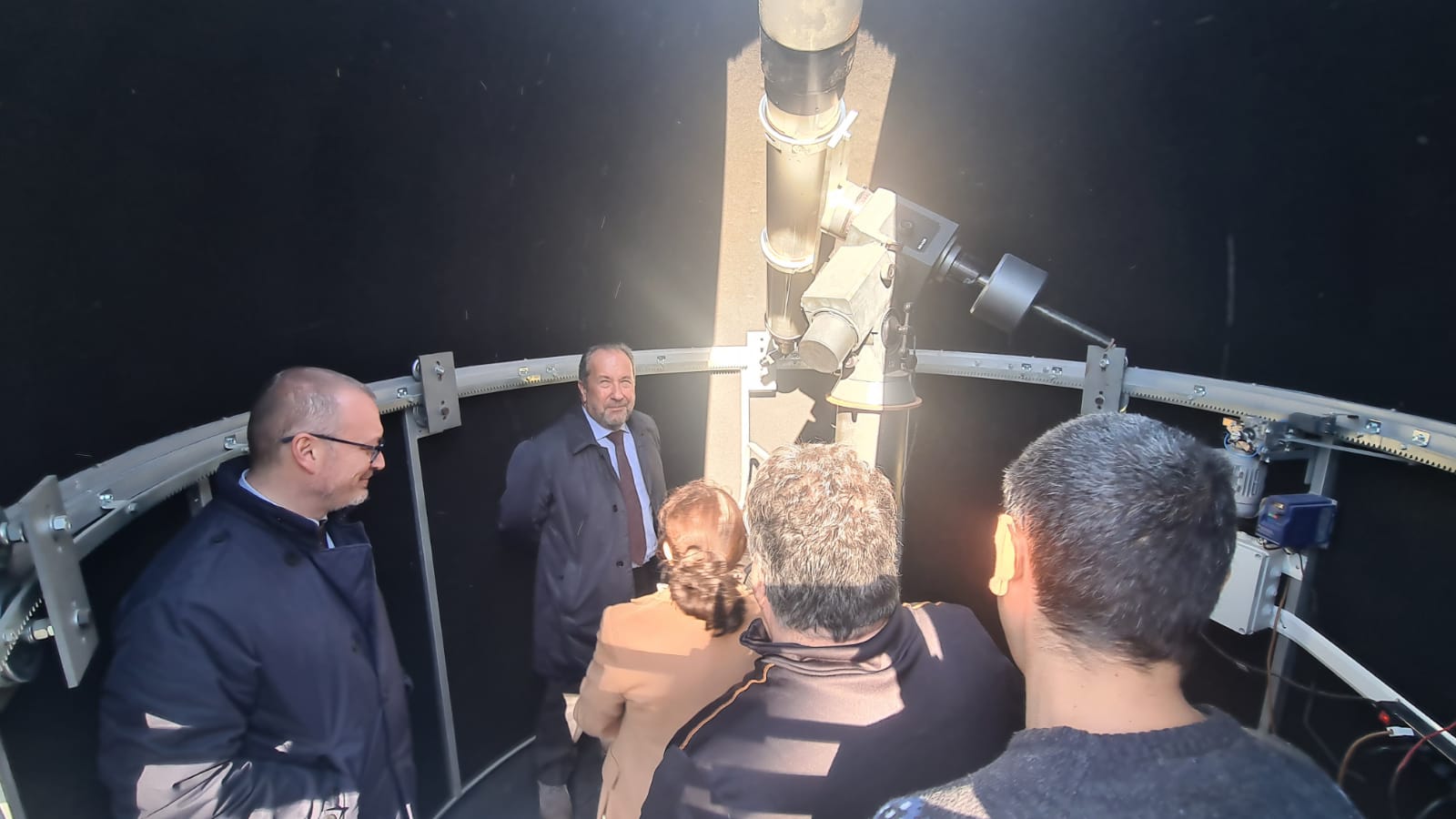




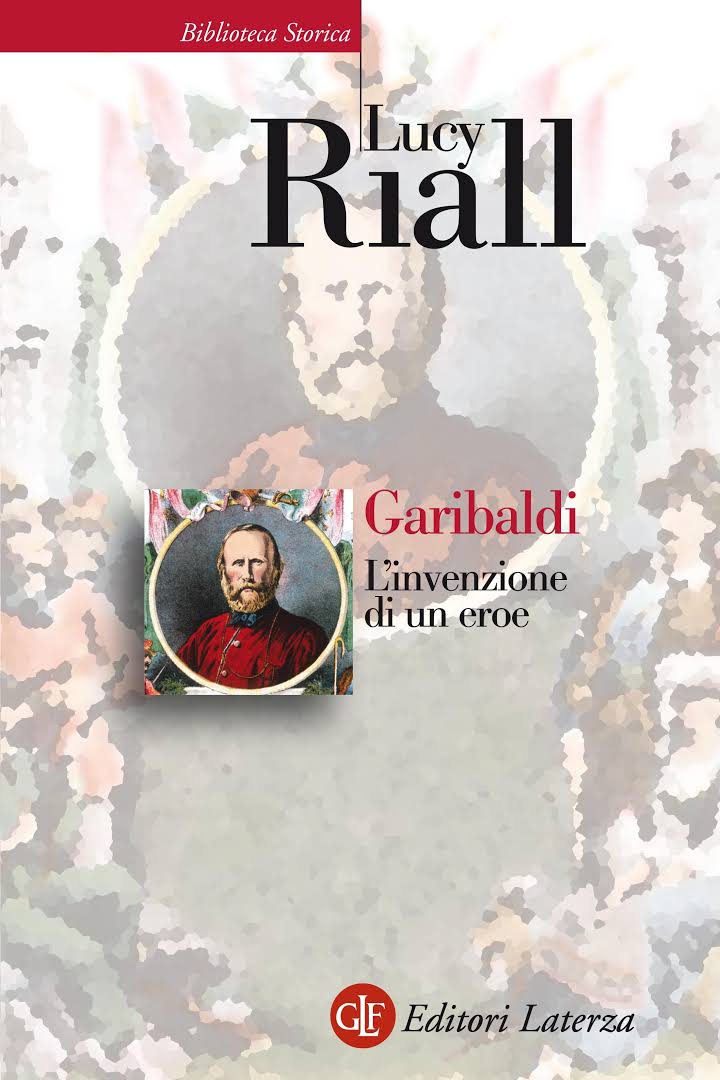











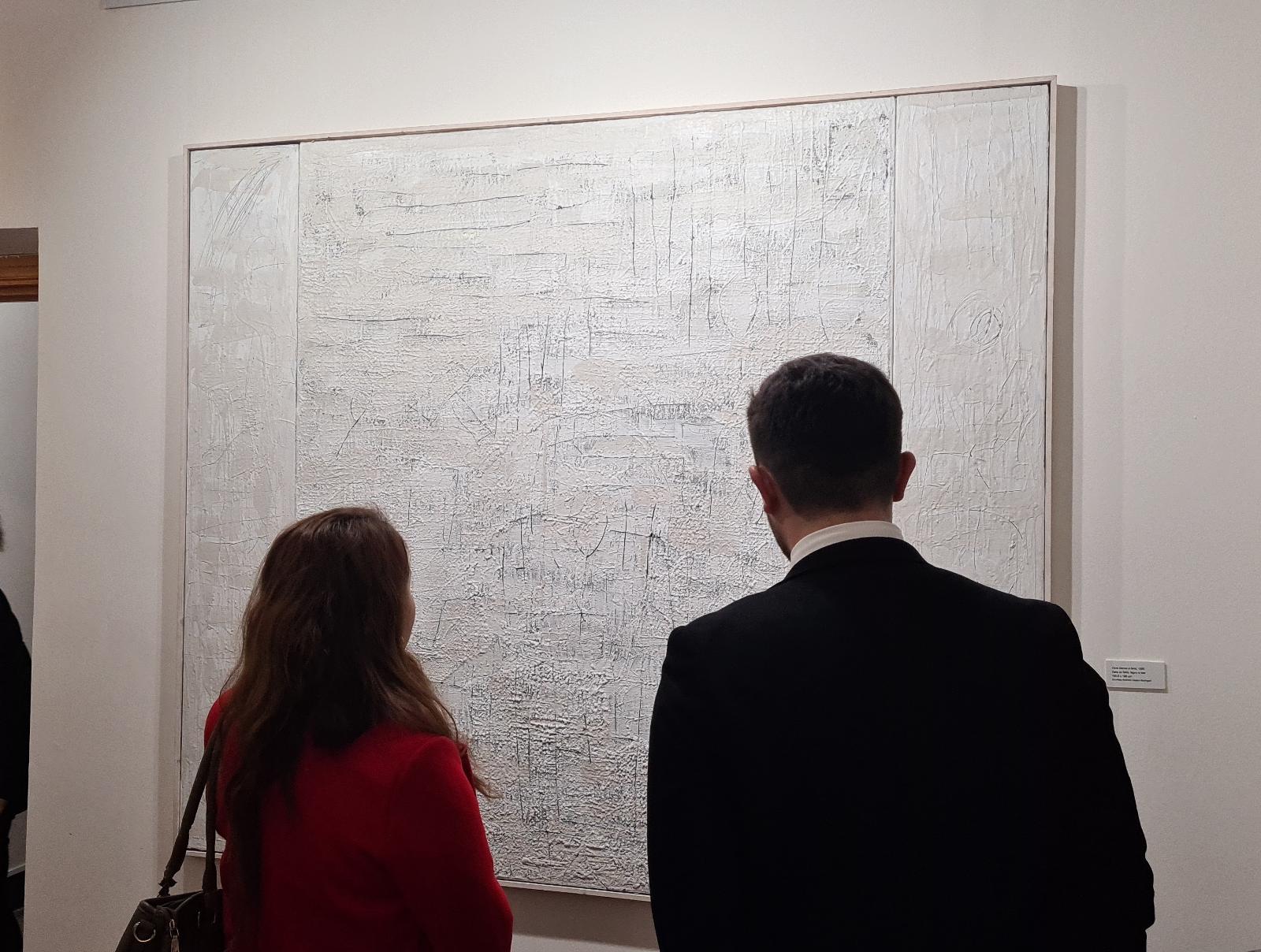










.jpg)










