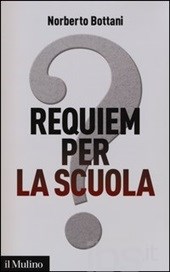Recentemente lo scrittore Salvatore La Porta ha pubblicato il libro "Less is more" (Il Saggiatore). Il titolo di questa opera editoriale rimanda ad una celebre frase contenuta in un monologo del poeta inglese R. Browning, ponendo il lettore dinanzi ad alcune considerazioni in merito ad una società sempre più "liquida", in cui i valori fondanti fanno rima con un consumismo per certi versi fuori controllo.
La necessità di certezze attraverso l'accumulo di cose, talvolta inutili, ci anestetizza, distogliendo la nostra attenzione verso gli aspetti esistenziali davvero meritevoli di attenzione.
Per contro, una parte del tessuto sociale è caratterizzata da condizioni di povertà e pesanti difficoltà di ordine pratico. Viviamo in una società nella quale il divario socio-economico sta diventando sempre più ampio; ma questo non sembra preoccupare chi, all'interno della propria "gabbia dorata", continua a rincorrere i beni materiali, alla ricerca di un appagamento, che alla lunga si rivela effimero.
Quel di più che viene dal meno, in un percorso volto alla ricerca dell’essenziale, che va controcorrente, in un tessuto sociale sempre più attento al raggiungimento della materia, dell’appagamento attraverso la quantità di cose delle quali disporre. È giunto il momento di fermarci seriamente a riflettere?
Credo che il momento sia arrivato da un bel pò, ed infatti l’umanità riflette da parecchio sull’effetto che i beni materiali hanno sulla nostra vita. Certamente il nostro periodo storico vede una divisione della popolazione sempre più marcata tra chi non ha niente e chi ha moltissimo, e l’accumulo di proprietà è uno dei metodi con cui il consumismo mette a tacere la nostra coscienza. Non si tratta soltanto di avidità: più accumuliamo, più il nostro posto nel mondo diventa stabile e limitante. Sappiamo benissimo che, in cambio del benessere, abbiamo rinunciato al nostro senso di giustizia, ma la fatica necessaria a mettere in discussione la nostra posizione nella società è sufficiente a farci voltare la testa. Più che l’avidità può l’abitudine.
Secondo lei, quali sono le dinamiche attraverso le quali l’uomo del Terzo Millennio si è così avvicinato, forse inconsapevolmente, al livello di saturazione?
Credo che una parte fondamentale di questa “trappola” sia costituita dalla vigliaccheria; pochi occidentali ignorano le condizioni di chi è stato sacrificato perché noi potessimo accumulare una tale quantità di cibo, oggetti e benessere (fisico, almeno). La sproporzione tra le nazioni più ricche del mondo e quelle più sfruttate è stata raccontata da centinaia di voci e, se non fossero sufficienti i racconti, abbiamo il mar Mediterraneo pieno di morti a mostrarcela.
Le nostre proprietà, però, significano soprattutto il nostro “posto nel mondo”; è più facile rinunciare all’avidità che riconfigurare da capo la propria vita. È in questa maniera che abbiamo perso il coraggio di aiutare gli altri: siamo terrorizzati dall’idea di dover cambiare vita.
Ritiene che la ricerca spasmodica della materia, che va ben oltre il necessario, sia riconducibile alla nostra infelicità?
Se l’accumulo di beni materiali fosse un buon metodo per essere felici, l’occidente sarebbe il paradiso terrestre. Non sto assolutamente dicendo che chi è povero è più felice di noi: la miseria è una malattia sociale e chi ne è colpito non ha alcuna scelta. Non c’è alcuna libertà nella povertà.
Ma se bastasse la ricchezza a farci felici, perché la nostra società è così palesemente in crisi? In realtà, accumulare proprietà ci allontana da noi stessi, ci costringe ad una serie limitata di ruoli, ci impone delle regole che delimitano la nostra capacità di scegliere. Le nostre proprietà sono statiche e pesanti, noi siamo dinamici e mutevoli; il contrasto tra queste due essenze ci fa sentire infelici.
Forse la ricerca della materia rappresenta un tentativo di colmare i troppi vuoti esistenziali?
Cerchiamo di colmare la differenza tra quel che sentiamo di essere e quel che siamo obbligati ad essere. Ma questa differenza è creata proprio da ciò che abbiamo accumulato durante la vita: siamo stati fissati dai nostri beni nel ruolo di padre, direttore, marito, impiegato. Ma l’essere umano è inevitabilmente più ricco e cambia con il tempo. L’impiego che desideravamo a vent’anni può essere il nostro incubo a quaranta. La casa che abbiamo voluto s’è trasformata in un mutuo. La nostra famiglia in un incubo. Fuggire da queste gabbie è difficile; serve un coraggio ed una fatica che spesso non abbiamo. Allora accumuliamo altre proprietà, cerchiamo un sollievo che rende soltanto più crudele la trappola in cui siamo caduti. È un meccanismo molto naturale, lo stesso delle sabbie mobili.
Quanto potrebbe giovare all’uomo riacquistare una certa capacità di discernimento fra il necessario, l’utile e il superfluo, in un’ottica di alleggerimento mentale?
Sarebbe fondamentale. Ma potrebbe rivelarsi inutile; comprendere quale sia la nostra essenza, quali siano i nostri veri desideri, è una pratica relativamente facile. Almeno se confrontata con il passo successivo; avere il coraggio di spezzare la catena delle abitudini e rinunciare al superfluo, riprogrammare la propria vita, mettere in discussione le basi sulle quali l’abbiamo costruita e che adesso sono diventati ceppi.
In un capitolo della sua interessante opera, intitolato "Il rischio di una morte quotidiana", fa riferimento ad un personaggio dell’album "Storia di un impiegato", in cui il cantautore F. De Andrè affronta per la prima volta il tema della lotta al sistema da parte dei movimenti giovanili. Vorrebbe parlarne ai nostri lettori?
Storia di un impiegato è uno dei dischi più belli di De Andrè. Soltanto la Buona Novella mi affascina di più. Dentro quel disco c’è un personaggio stupendo, un impiegato che vorrebbe partecipare ai movimenti del Sessantotto, alla lotta politica, all’amore libero, all’arte nuova e ricca di quegli anni, ma si trova in ritardo: ha dieci anni in più dei protagonisti del Maggio francese, ma soprattutto ha una moglie, un lavoro, delle proprietà. L’unico modo che gli rimane per seguire i propri desideri ed il proprio senso di giustizia è far esplodere, letteralmente, la gabbia che lo circonda: diventa un bombarolo, finisce in carcere. E si conquista una strana felicità.
Un suo suggerimento per iniziare a coltivare la cosiddetta “arte di non avere niente”?
Coltivare l’indipendenza ed il coraggio. Il più possibile.








.png)


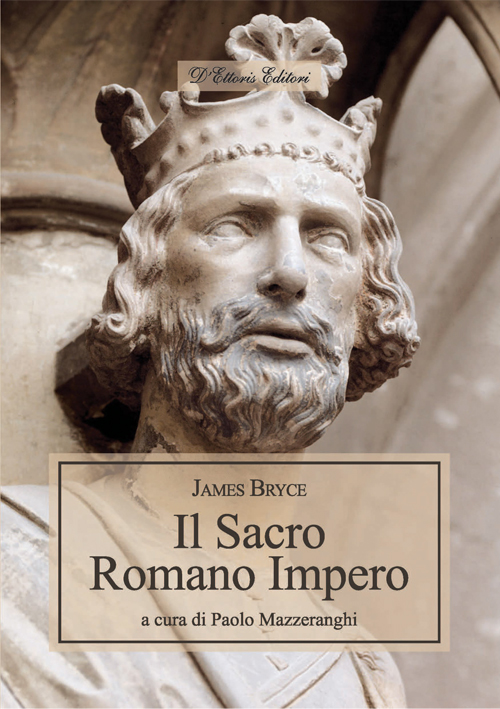
.jpg)



















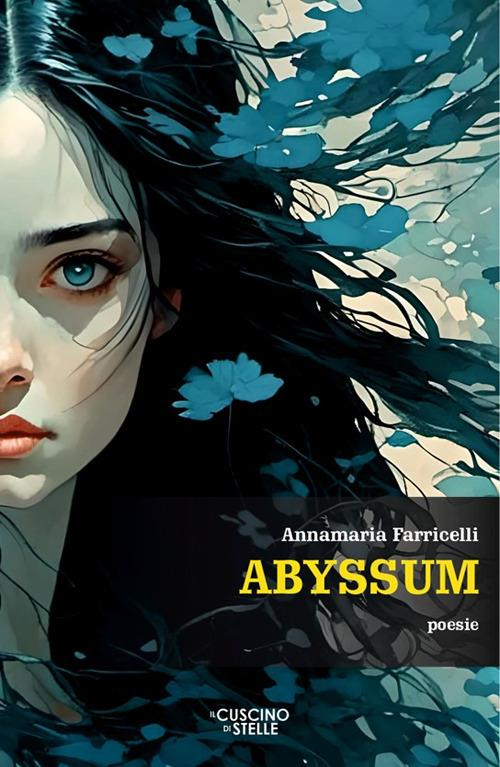





.jpg)









.jpg)










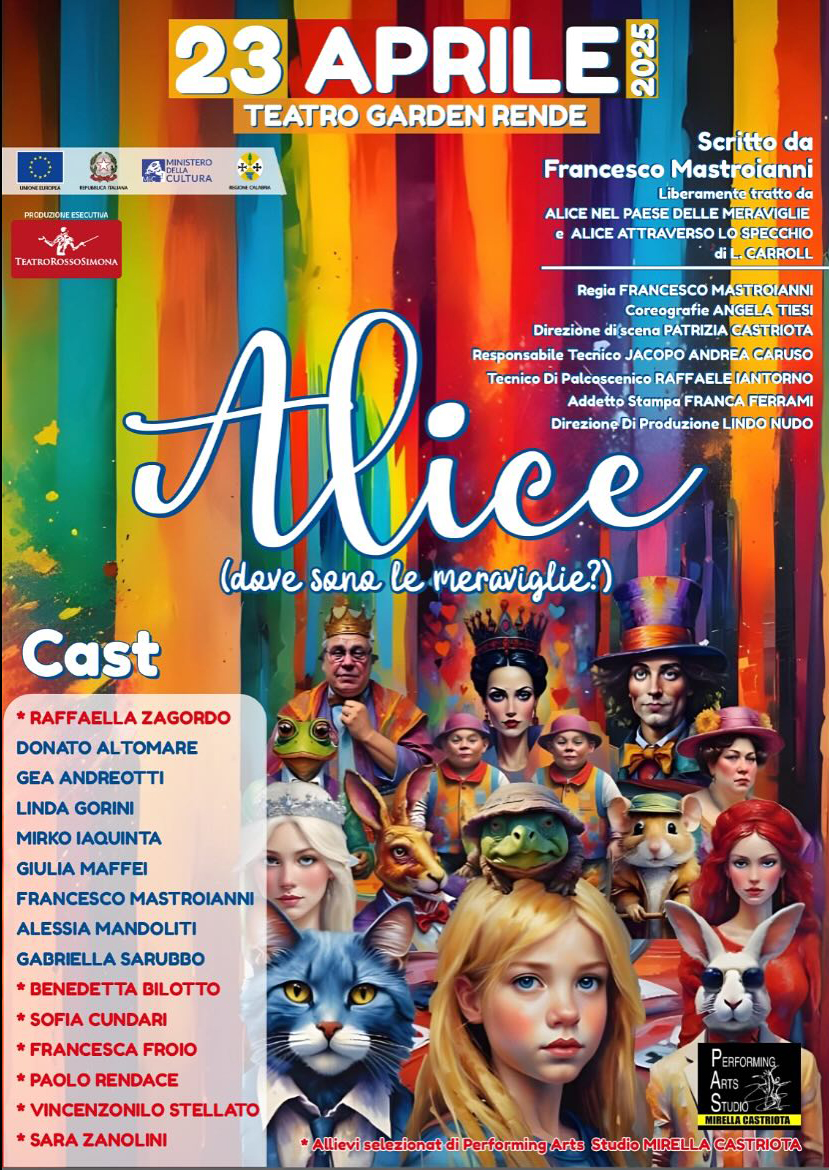



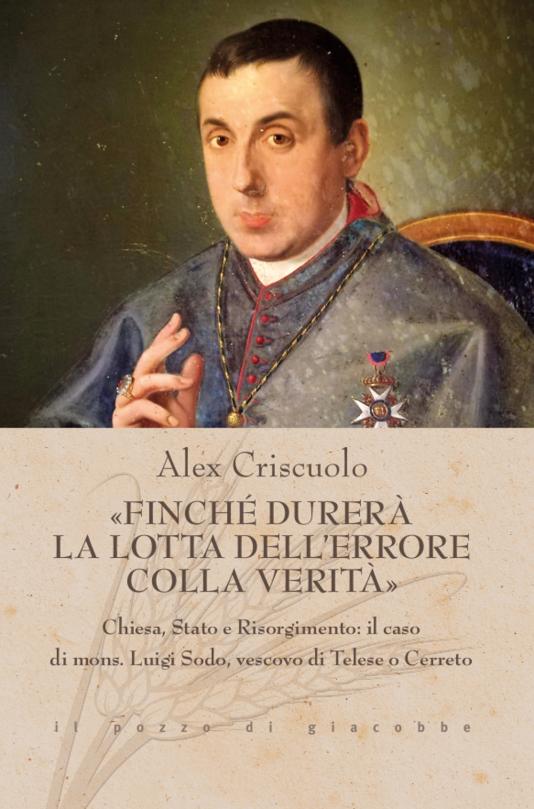













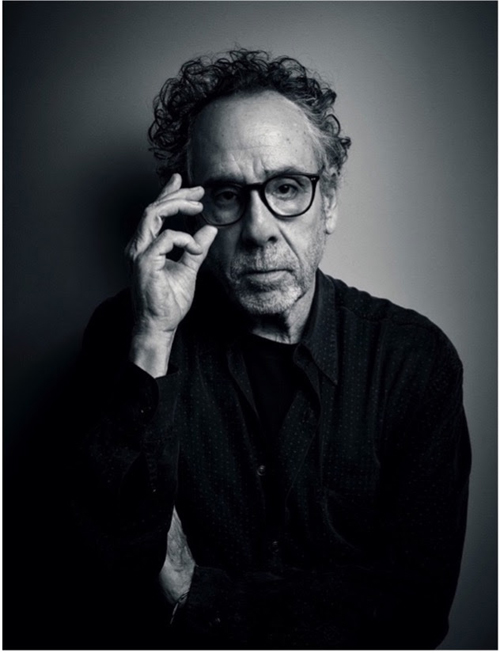





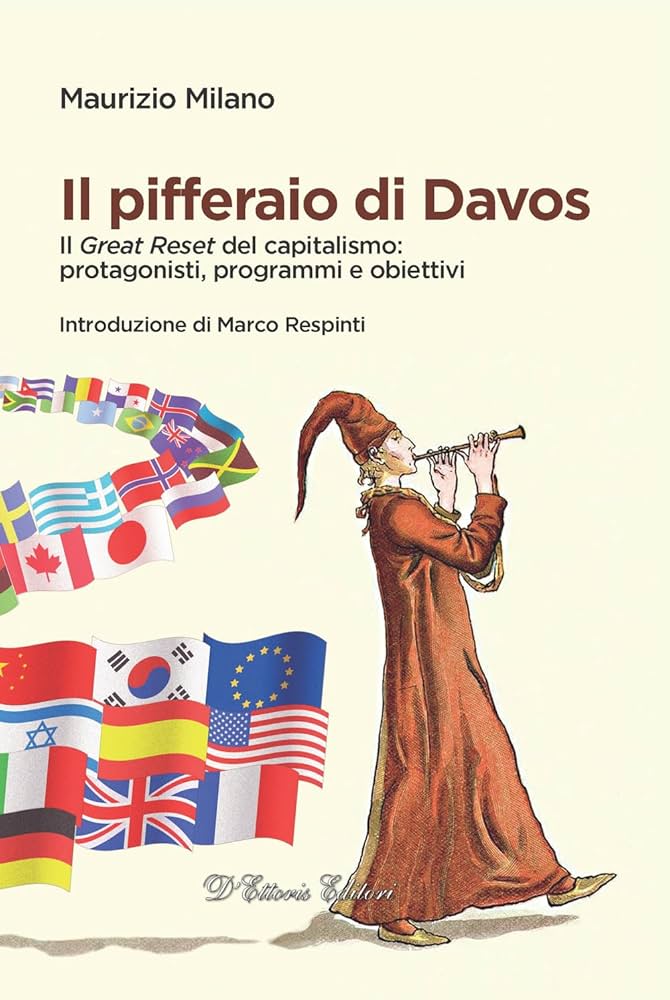



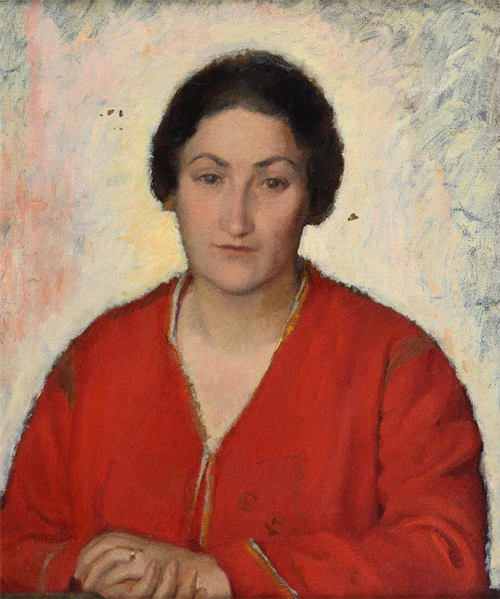














.JPG)







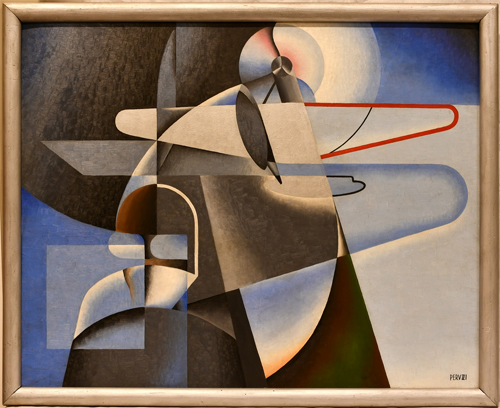




.jpg)
.jpg)