
Se il nostro tempo non fosse generalmente refrattario a una pedagogia fondata sul principio di autorità e sulle prescrizioni, modello «compiti a casa», ai nostri politici dovrebbe essere imposto lo studio, più che la mera lettura, dell’opera di Christopher Caldwell, Reflections on the Revolution in Europe (il titolo è un trasparente omaggio alle Reflections di Edmund Burke [1729-1797]), fruibile anche in una pregevole e tempestiva traduzione italiana presso Garzanti, con il titolo L’ultima Rivoluzione dell’Europa. L’immigrazione, l’islam e l’Occidente.
Il giornalista statunitense, che lavora a The Weekly Standard e collabora con prestigiose testate come Financial Times, Slate, The New York Times, Wall Street Journal, The Washington Post, studia da tempo il fenomeno dell’immigrazione in Occidente e particolarmente in Europa, e ha in qualche modo organizzato i suoi numerosi interventi sull’argomento in questo volume. Esso ha forse il carattere del pamphlet, pur essendo tutt’altro che breve, in quanto di facile e scorrevole lettura e soprattutto portatore, e non senza un sano spirito polemico, di una tesi ben precisa. Ma è certamente ben argomentato e documentato, sì da avvicinarsi al saggio, e perciò costituisce un testo imprescindibile per una seria discussione e per riconoscere i problemi che l’immigrazione comporta, al fine di affrontarli con competente responsabilità e non rimanere stupiti, quando non stupidi, nel momento in cui maturano ed esplodono, talvolta con tragica virulenza.
Caldwell, genero del giornalista cattolico conservatore Robert Novak (1931-2009), con dovizia d’informazioni di prima mano e mostrando una singolare – per un giornalista americano – conoscenza della politica europea e dei suoi protagonisti, affronta il tema dell’approccio occidentale all’immigrazione come tendenza, come ideologia e come fatto. Quest’analisi globale lo induce a cogliere, non senza allarme, la potenzialità, se non proprio la realtà, rivoluzionaria dell’immigrazione contemporanea, soprattutto in connessione con due fenomeni tipicamente europei che con essa interagiscono: la denatalità, che assume il carattere di autentico «suicidio demografico», e la crisi d’identità, che sempre più somiglia alla condizione tipica, secondo il modello psichiatrico, dello smemorato.
La questione dell’immigrazione in Europa nella seconda metà del secolo XX trascende la mera analisi sociologica, economica, culturale, di un fenomeno storico, per quanto di vasta portata, quasi epocale. Essa ha assunto il carattere di un’ideologia, generata e alimentata soprattutto da tendenze – inclinazioni psicologiche –, che, dalla fine della seconda guerra mondiale e specialmente fino agli anni 1970-1980, hanno provocato nell’anima dell’uomo europeo profonde trasformazioni culturali e di sensibilità, per così dire. Se l’ideologia dell’immigrazione è stata definita dal filosofo francese Pierre-André Taguieff immigrationisme, immigrazionismo, le tendenze che l’hanno generata e la alimentano sono da individuare in un diffuso complesso di colpa per le malefatte colonialiste cosiddette, e più in generale per lo sfruttamento con il quale l’Occidente si sarebbe fatto ricco e potente ai danni delle popolazioni e dei mondi da cui muovono i «migranti». «Da un certo momento in poi, fu possibile avere un’unica opinione accettabile in materia, e cioè che l’immigrazione era un successo e un “arricchimento” per la società. Definirla un fallimento equivaleva a proclamarsi razzisti; esprimere qualche dubbio era come confessare inclinazioni razziste. […] l’immigrazione sarebbe sempre “inevitabile e buona”» (Caldwell, p. 112 [i riferimenti senz’altra indicazione oltre il numero di pagina sono all’opera recensita nella sua edizione italiana del 2009]).
Il fatto immigrazione assume perciò una dimensione qualitativa che va ben oltre la sua dimensione quantitativa, pure abnorme e soprattutto in costante se non geometrica crescita. Da un lato, per troppi europei, soprattutto membri delle élite politiche e intellettuali, è diventato una via per espiare reali o solo pretese colpe dell’Occidente, ovvero il modo privilegiato di attuazione di un modello relativista e multiculturale, e dunque per decenni è stato favorito indiscriminatamente, senza mai porsi seriamente il problema di come disciplinarlo e poi di come regolarsi con gl’im-migrati. Dall’altro, per molti, troppi, di questi ultimi, l’immigrazione ha acquisito il carattere della rivincita, magari proprio sotto l’influenza dello stato d’animo, prima ancora della cultura, corrente in Occidente.
Le teorie successive – come quelle che fanno perno sulle necessità economiche e sociali che consigliano di tenere aperte le porte agl’immigrati, perché gli unici disposti a fare lavori che i nativi ormai rifiutano, ovvero perché senza di loro non sarebbe possibile sostenere il nostro welfare –, spesso elaborate per giustificare l’immigrazionismo, non reggono all’esame econometrico più elementare. Quanto ai «lavori che gli europei non vogliono più fare», si tratta solo di capire che sono lavori che i nativi rifiutano perché scarsamente retribuiti, perciò destinati a scomparire, ovvero a essere rifiutati dagli stessi migranti man mano che si radicano. Quanto al welfare, si calcola che per compensare gli effetti del combinarsi di denatalità e allungamento della vita media, e cioè per ripristinare nel rapporto tra lavoratori e pensionati, che ormai tende verso due a uno, il più sostenibile quattro a uno, occorrerebbero in Europa settecento milioni di immigrati… (pp. 51-61)
Ma il problema è ancora più profondo e grave, e perciò Caldwell parla di Rivoluzione, intesa nel senso di «cambiamento sociale» (p. 352), del perfezionamento della trasformazione radicale del nostro mondo storico e della nostra civiltà, un’autentica sovversione, che va dall’ethos agli assetti ordinamentali europei, coinvolgendo anche la stessa libertà religiosa. Che cosa sono, infatti, la tendenza a mettere in sordina il Natale e i suoi simboli, la guerra al crocifisso e l’occupazione islamica dei sagrati delle chiese per la preghiera – ciò che ha per i musulmani una fortissima valenza socio-religiosa – se non modalità diverse e di diversa intensità, che va dal modulo dell’autocensura a quello dell’aggressività, della riduzione al privato degli spazi di libertà della religione cristiana in Europa? Con motivazioni anche opposte tra loro, ma che affondano le proprie radici nel multiculturalismo laicista, si tende a togliere spazio pubblico al cristianesimo in Europa, guardandosi bene, però, dal praticare la stessa misura con l’islam: l’islamofobia, non la cristianofobia, è un delitto!
Nel 1965, lo scrittore svizzero-tedesco Max Frisch (1911-1991), a proposito dell’immigrazione nella sua patria – ma il discorso è facilmente suscettibile di traslazione all’intera Europa – scrive: «[…] è stata chiamata mano d’opera e arrivano uomini». Si può aggiungere: e uomini che, in quanto tali, inevitabilmente portano con sé una cultura, che non può che essere anche, se non soprattutto, religiosa, e che nel caso dei musulmani è una cultura forte, molto forte e aggregante. Giungono cioè in Europa, più che individui, comunità. Comunità che lungi dal disperdersi sul suo territorio – come i due milioni di musulmani immigrati e residenti negli USA, comunque sottoposti a rigide politiche di assimilazione culturale, che l’autore definisce «procustee», (p. 362) – si concentrano, e fanno gruppo anche nello spazio. E tutto questo con una tendenza demografica alla crescita cui corrisponde, in una combinazione potenzialmente letale, la tendenza all’estinzione dei nativi europei. È questa l’immigra-zione che interessa davvero Caldwell, e che deve interessarci: quella intracomunitaria, o comunque religiosamente omogenea, come la latinoamericana, presenta molto meno problemi, quasi esclusivamente di sicurezza.
Le comunità islamiche – certo non monoliticamente omogenee, non riducibili ad unum, ma abbastanza omogenee, e comunque riconoscibili secondo parametri sufficientemente definiti – si confrontano quotidianamente con un uomo europeo che spesso, come è proprio dello smemorato, non sa chi è e che cosa dev’essere, e quindi assume identità sempre fluide e cangianti, fino a convincersi di non essere nessuno e di non dover essere niente. Il nichilismo europeo scandalizza tra gl’immigrati coloro che optano per il pensiero forte della propria identità – quale che ne sia la ragione – molto più della ferma rivendicazione della cultura e religione europee, che può tradursi nel «prendere o lasciare» rivolto all’immigrato rispetto ai costumi e ai principi propri del Paese in cui ha deciso di andare a vivere (cfr. pp. 366 e ss.). E così, parallelamente alla guerra terroristica all’Occidente – che, com’era facile prevedere, il nuovo clima da Nobel per la pace ha eccitato viepiù –, ai massacri periodici delle minoranze cristiane (indigene, beninteso, non immigrate) nelle aree a dominante sociale islamica, le comunità islamiche in Europa tendono a espandersi, a occupare il vuoto spirituale lasciato dai processi di secolarizzazione, e soprattutto a plasmare l’ambien-te sociale in cui si sono insediate, pretendendo persino di affiancare all’ordinamento giuridico vigente la shari’a, magari nella prospettiva di una totale sostituzione, attesa la sua superiorità morale.
Ma l’Europa politica e culturale, in molte sue componenti, ha forse poco da dire sul punto: «non sa più per quale ragione dovrebbe difendersi» (p. 372). E mostra anche di aver paura.
Da una parte, c’è una «destra» complessata che teme di passare per xenofoba e razzista – senza rendersi conto che spesso tali termini sono autentici strumenti balistici, ma privi di qualunque legame con la realtà – e perciò talvolta somiglia all’allievo che addirittura supera il maestro-sinistra in immigrazionismo. E in questo senso Caldwell descrive puntualmente le posizioni di Gianfranco Fini e Nicolas Sarkozy (soprattutto quando quest’ultimo era ministro dell’interno), irridendo le clausole da essi apposte alle proprie «aperture», e cioè che «gl’immigrati rispettino la legge», come se non fosse un’ovvietà (che però non risolve la questione del conflitto e dell’assimila-zione culturali per la salvaguardia dell’ethos europeo), e come se tra gli effetti delle politiche guidate dall’immigrazionismo non ci fosse anche il deficit di legalità in alcuni, ma non piccoli, ambiti delle comunità d’immigrati (cfr. pp. 335 e 340 e ss.).
Dalla stessa parte, poi, ci sono una «destra» e una sinistra, unite da anti-ameri-canismo e anti-sionismo, quest’ultimo spesso maschera di un antisemitismo o almeno di un antigiudaismo di fondo, e che vedono negl’immigrati «credenti», quindi specialmente in quegli islamici, un alleato oggettivo contro americanizzazione e giudaizzazione.
Dall’altra, c’è una sinistra alla perenne ricerca di un «proletariato interno», per dirla con Toynbee (1889-1975), visto che quello autoctono tende all’estinzione – e cioè non tanto di un gruppo definito socialmente, quanto di gruppi radicalmente ostili all’ordine e alla tradizione culturale occidentali (fa niente se poi il loro modello sociale, almeno in alcune parti, dovrebbe far paura a questi sinistri più di quanto avversino quello che combattono), ché in tal senso va inteso il concetto rivoluzionario di proletariato –, che possa rimpinguare la propria base elettorale (nella più benevola delle ipotesi).
Contro l’immigrazionismo e i suoi effetti, dunque, restano due opposizioni.
Il radicalismo libertino, anch’esso nichilista, che correttamente intravede nelle culture comunitarie di larga parte dell’immigrazione in Europa una minaccia per i propri «principi non negoziabili»: l’assoluta libertà sessuale e l’assoluta indifferenza dei generi (meglio, dei sessi), nonché tutte le libertà legate ad un’idea di autodeterminazione priva di qualsiasi normazione sociale ed etica, e cioè totalmente individualistica. È l’opposizione alla religione e alla sua rilevanza sociale, che fiancheggia la burocrazia e le istanze giudiziarie della UE nella loro ostilità al cristianesimo, ma se ne distanzia per la debolezza nei confronti dell’immigrazione islamica, di cui teme possa prendere il posto dell’ormai superato cristianesimo. È difficile, tuttavia, pensare che l’edonismo nichilista e individualista che lo ispira gli consenta di opporsi in modo organico e oserei dire militante alle temute conseguenze sociali dell’immigrazionismo. L’appello libertino edonista non solo non sembra un richiamo forte, ma soprattutto appare contraddittorio in se stesso per la sua anima individualistica.
Rimane allora l’opposizione fondata sulla piena consapevolezza di ciò che ha dato forma all’Europa, continente culturale e non geografico: la sintesi – non sempre ben attuata e rispettata, ma certo feconda di civiltà – tra la fede cristiana, la ragione ellenica e il diritto romano. Realtà impegnative e che forse dicono poco ai nostri contemporanei in termini concettuali, ma molto dicono in termini di buon senso, soprattutto da quando essi sono stati «assaliti dalla realtà» dell’immigrazione comunitaria di massa, e dell’islamismo come «fenomeno sociale totale» (p. 303). Infatti, i popoli europei, per quanto afflitti da quella crisi di smemoratezza cui più sopra si è fatto cenno, sono in larghissima maggioranza contro l’immigrazione incondizionata e non governata. Sono affezionati, anche se poco o per niente praticanti, ai simboli della loro religione, che stanno ricominciando almeno a stimare e difendere perché avvertono minacciata da religiosità estranee. Sono soprattutto contro la declinazione relativista e neutralista del multiculturalismo, come appare evidente dal risultato – democratico – del referendum svizzero sui minareti del 2009. Tale orientamento però è un problema per la democrazia e per i politici europei abbagliati dalla missione immigrazionista – la trasformazione in senso multietnico e multiculturale delle società europee –, come appare evidente dal rifiuto del risultato di tale referendum nelle reazioni ufficiali degli «abbagliati» e dei «missionari», perché in questo modo essi mostrano di non rispettare le maggioranze, che pure hanno i loro diritti (p. 353).
Quanto possa quest’ultima opposizione costituirsi e agire, è difficile dirlo. Essa è evidentemente in fieri, e scritti come quello di Caldwell, benché non tutti i suoi giudizi siano condivisibili da questo punto di vista, possono aiutarla a formarsi. Certamente non è ancora iscritta all’anagrafe, ma è già nata: pochi tra i politici e intellettuali d’Europa vogliono darle il nome e riconoscerla, ma tra i popoli è viva. Le politiche dell’allora governo italiano e le posizioni della Lega Nord, per esempio, non solo non vengono liquidate dall’autore come razziste o xenofobe, ma traspaiono in filigrana nelle sue domande e nei suoi abbozzi di risposta, come una possibile alternativa.
Non si tratta – è evidente – di azzerare l’immigrazione o di espellere tutti gl’immigrati. L’Europa autentica – quella che vorremmo socialmente ri-fondata sulle proprie radici, il connubio fecondo tra fede, ragione e diritto, cioè sul diritto naturale – si suiciderebbe culturalmente se si chiudesse in se stessa e se negasse l’umanità, e i correlativi diritti e personalità, dei migranti. Chi non vuole che sia negata ai feti, non vedo come potrebbe negarla agli uomini immigrati. Ma anche il magistero della Chiesa – che è cosa diversa dall’opinione degli ecclesiastici – riconosce la legittimità di politiche dell’immigrazione volte a tutelare il bene comune dei popoli verso cui questa si dirige e la loro identità culturale e religiosa (cfr., fra i tanti pronunciamenti, l’enciclica Caritas in veritate, n. 62). La dottrina sociale della Chiesa non solo non nega le frontiere, ma affida ai politici la responsabilità della loro salvaguardia e del-l’individuazione delle soluzioni tecniche allo scopo, senza dimenticare che l’emigra-zione di necessità è un male, e depaupera di risorse umane gli stessi popoli in cui si verifica, per cui anziché favorita, meglio sarebbe adoperarsi provando a rimuoverne le cause in loco. Naturalmente, nessuno può negare all’immigrato ormai giunto i diritti fondamentali della persona umana, ma nessuno può impedire di chiedergli di osservare i doveri che ne derivano altrettanto fondamentalmente, e l’ethos del Paese in cui si è recato (certo diventa un problema quando questo Paese il suo ethos l’ha dimenticato: è allora indispensabile e preliminare restituire la memoria a chi l’ha persa).
Se l’Europa non è in grado di sopportare né la malattia, rappresentata dalle sperimentate ricadute sociali – le rivolte, la pressione religioso-culturale, la solidarietà quando non la complicità attiva con il terrorismo, l’illegalità diffusa, i diversi costumi familiari e sessuali – di decenni di immigrazione di massa incontrollata e identitaria, soprattutto islamica, né la cura, da individuare nella linea dura finalizzata all’assimi-lazione (che per Caldwell, soprattutto se riferita all’immigrazione islamica, ha bisogno di tempi lunghi o lunghissimi e adeguata fermezza), allora il problema appare di difficile soluzione.
Ma i problemi – e l’immigrazione di massa incontrollata è certamente un problema, che non sarà il mantra dell’«accoglienza» senza se e senza ma a renderla ipso facto una risorsa – non si risolvono negandoli, o con le scorciatoie come la cittadinanza facile (la cittadinanza può essere un punto d’arrivo, non di partenza), o stupidaggini politicamente corrette come l’ora di Islam a scuola. Essi consistono in domande non più eludibili, come «[…] può l’Europa rimanere sé stessa pur ospitando una popolazione diversa?». Secondo l’autore, «la risposta è no» (p. 35). Perché, «quando una cultura insicura, malleabile, relativista incontra una cultura ancorata a delle dottrine comuni che le infondono forza e fiducia, è generalmente la prima a cambiare per uniformarsi all’altra» (p. 374).
Credo pertanto che la più urgente missione per l’Europa sia ricostruire la coscienza della propria identità sulle fondamenta del pensiero forte che l’ha formata. Allora nessuna immigrazione potrà più farle paura, com’è accaduto nei secoli passati.








.png)


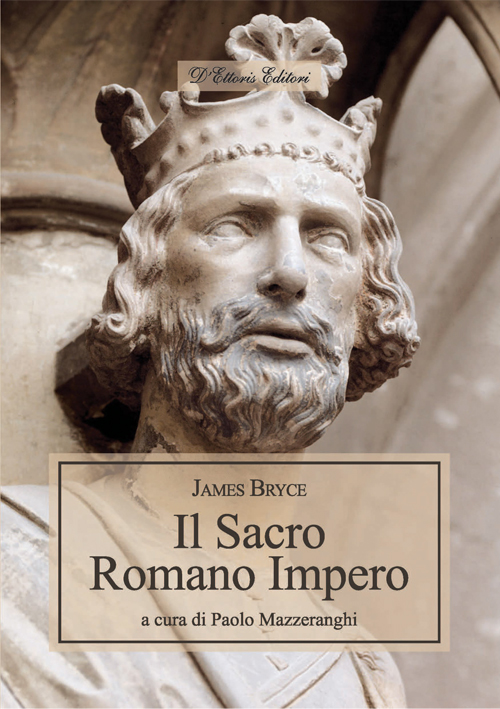
.jpg)



















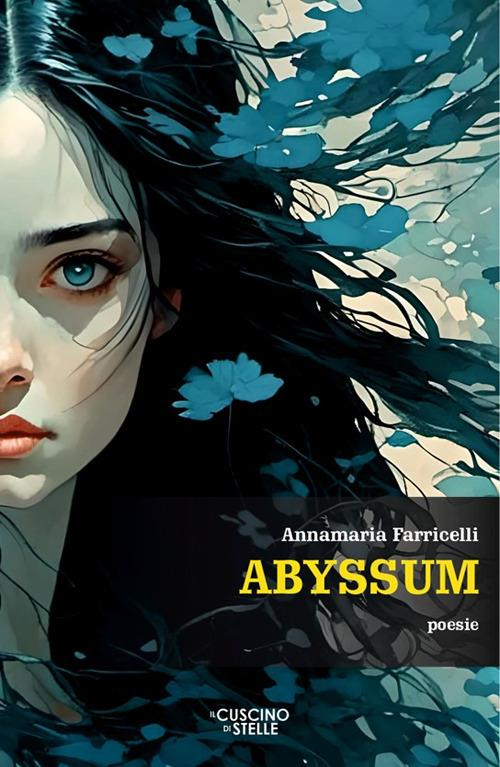





.jpg)









.jpg)










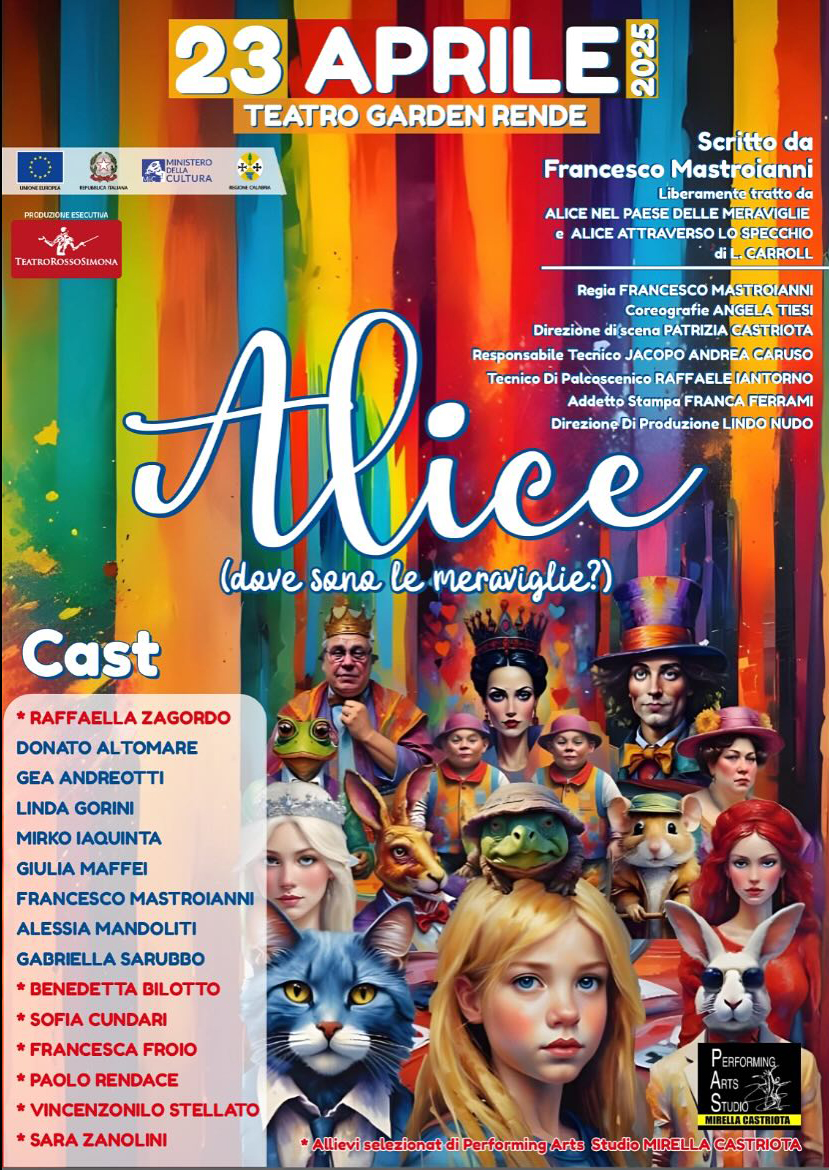



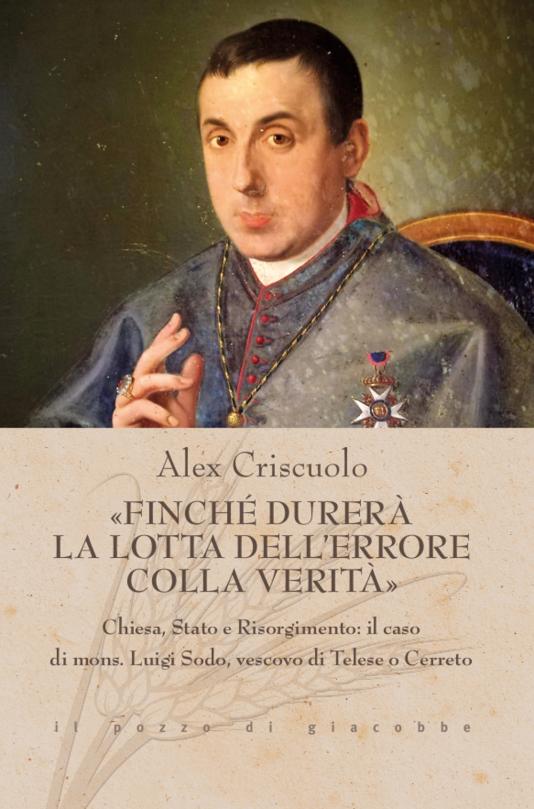













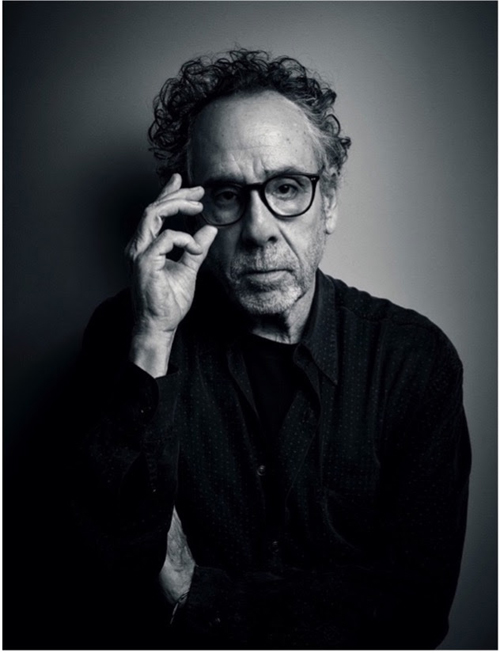





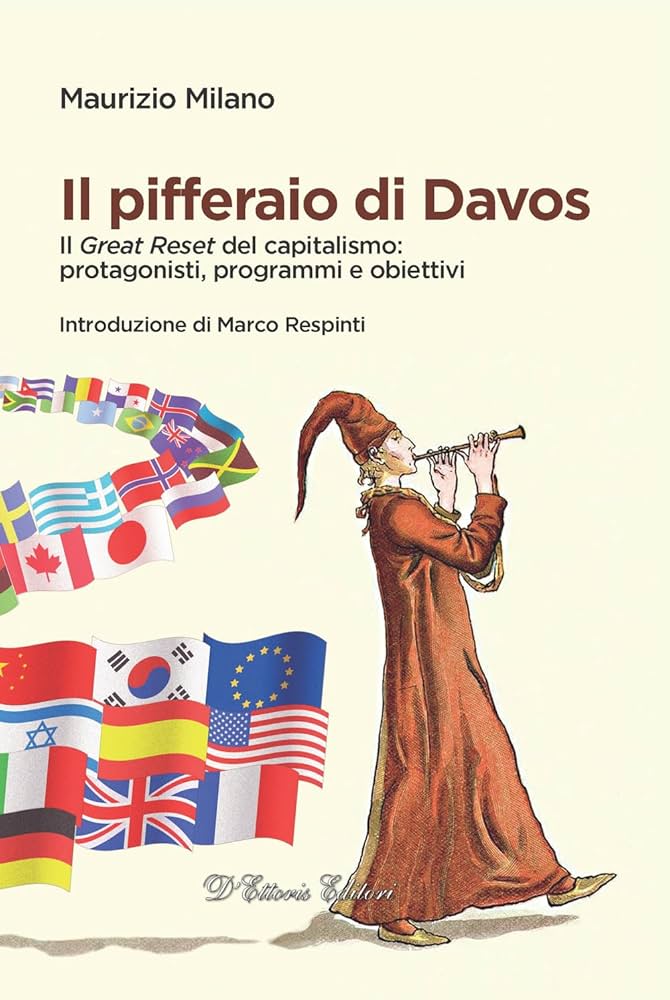



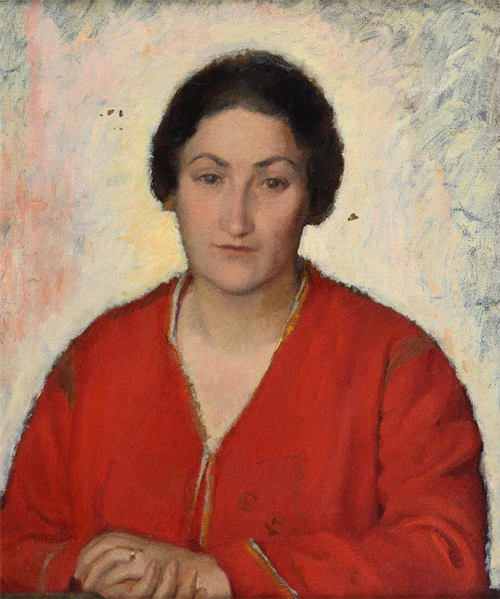



















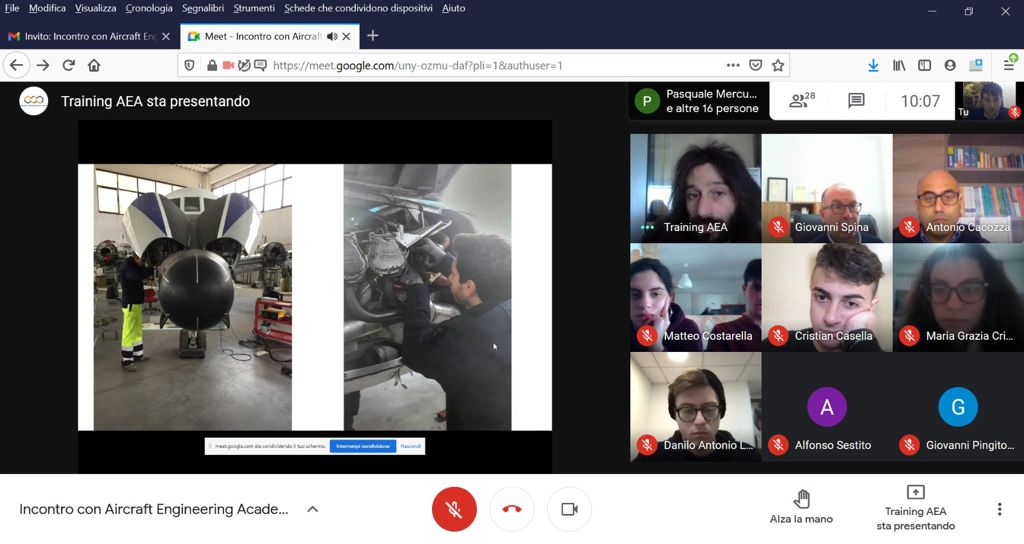











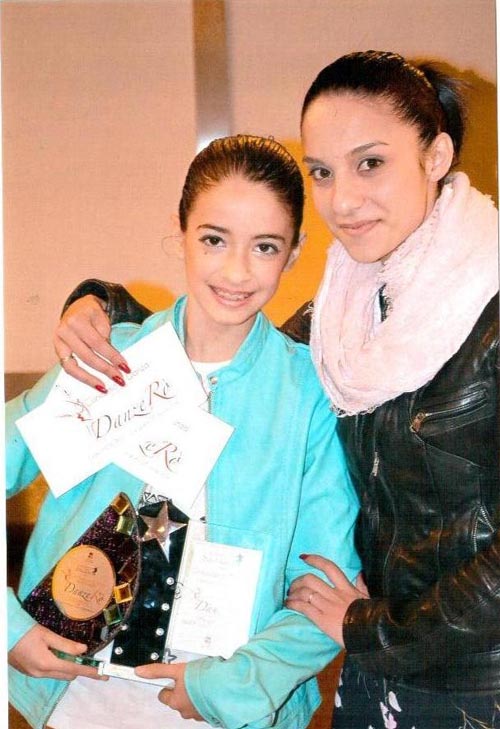







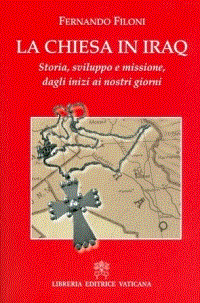





.jpg)












.JPG)




