Antistoria del Risorgimento e del Brigantaggio

A che serve a distanza di oltre un secolo conoscere come i Piemontesi hanno “liberato” il Meridione d'Italia? Forse per capire il perchè è nata la cosiddetta “questione meridionale”? Oppure soltanto per conoscere la vera Storia del Sud e del sistema che lo governava, cioè il Regno delle due Sicilie dei Borboni.
Tempo fa un parente, conoscendo la mia predilezione allo studio della storia del Risorgimento e del Brigantaggio, mi diceva che dopo aver letto una recensione dell'ultimo libro di Pino Aprile, si interrogava se le notizie riportate da Aprile erano vere o montature. Pazientemente ho risposto che ormai è da tempo, almeno dalla caduta del Muro di Berlino, che esistono fior fiore di testi, di studi, che hanno raccontato dettagliatamente come è stato conquistato il Sud dopo la cavalcata liberatoria di Garibaldi. Aprile non fa altro che raccontare giornalisticamente come sono andati i fatti.
Per non perdere l'abitudine dei miei studi in queste fredde serate di dicembre ho letto uno dopo l'altro i testi di Giordano Bruno Guerri, “Il sangue del Sud. Antistoria del risorgimento e del brigantaggio”e“Il Bosco nel cuore. Lotte e amori delle brigantesse che difesero il Sud”, entrambi pubblicati da Mondadori, il primo nel 2010, il secondo nel 2011, collezione“Le Scie”.
I testi di Guerri si occupano“dei modi e dello spirito con cui fu compiuta l'impresa (la conquista del sud) e delle sue conseguenze”. Pertanto si pone alcune domande“Quali tragedie e ingiustizie la accompagnarono?”. Si è fatto di tutto per integrare davvero le identità, le culture, le tradizioni, persino le lingue diverse? Oppure si era fatta l'Italia, ma non si sono fatti gli italiani, come diceva Massimo D'Azeglio, che peraltro, temeva la fusione coi napoletani.
Giordano Bruno Guerri sicuramente non è un nostalgico del Regno delle Due Sicilie, è uno storico liberale che coraggiosamente racconta gli avvenimenti con serietà e imparzialità, utilizzando le numerosi fonti e documenti che ormai da tempo sono a disposizione di chiunque voglia fare storia seria. Peraltro nei suoi testi troviamo una bibliografia essenziale che fa riferimento a tanti storici che hanno ben studiato quegli anni tanto tormentati.
Guerri non disdegna di polemizzare con la storia ufficiale raccontata dai vincitori, ironizzando sui “liberatori” piemontesi, che secondo la vulgata, dovrebbero rappresentare “i civilizzatori”, i portatori di giustizia e legalità, mentre gli altri, i meridionali, sono briganti. Questi ultimi fin dalla Rivoluzione Francese, sono stati screditati dagli intellettuali, dai politici. La loro opposizione veniva rappresentata come “viscerale manifestazione di rancori e pulsioni irrazionali”, mentre si trattava, “di una resistenza ideologica e politica, oltre che sociale”. Ma per liquidarla gli illuminati giacobini, collegavano la rivolta popolare“al delitto comune”. Così accadde anche in Italia dove per i nostri intellettuali benpensanti“la ribellione di reazionari, contadini e clericali, contro lo Stato appena costituito fu etichettata 'brigantaggio'”. Pertanto Guerri può scrivere che al Sud, tutti erano briganti, banditi, criminali comuni, mentre gli altri che venivano dal Nord erano i liberatori.“Due mondi erano in conflitto tra loro. Perchè l'uno venisse a patti con l'altro occorreva che il vincitore riconoscesse le differenze e cercasse di cancellarle realizzando una maggiore giustizia sociale. Invece scrive Guerri, “si preferì l'azione repressiva, determinata a stroncare, soffocare, estirpare. Una logica che alimentò se stessa: la violenza ne generò altra, sempre più crudele”.
Come quella che si è manifestata in una notte d'agosto del 1861 a Pontelandolfo e Casalduni nel beneventano, l'esercito piemontese per vendicare i suoi uomini, non esitò di massacrare quasi un migliaio di uomini e donne di questi paesi.
I meridionali dagli ufficiali e soldati italiani furono percepiti come una razza inferiore, ma nello stesso tempo, Guerri considera questi soldati che andarono a combattere una sporca guerra, furono forse i meno colpevoli, “furono l'ultimo anello di una catena di errori e orrori[...] furono vittime, come i loro nemici, di una carneficina che poteva essere evitata”. Le colpe maggiori sono di chi dirigeva il Regno sabaudo, con la legge Pica del 1863, il governo di Torino,“in pieno accordo con il Parlamento, impose lo stato d',assedio annullò le garanzie costituzionali, trasferì il potere ai tribunali militari, adotta la norma della fucilazione e dei lavori forzati, organizzò squadre di volontari che agivano senza controllo, chiuse gli occhi su arbitrii, abusi, crimini, massacri”. Per i Savoia,“i briganti erano l'emblema di quel figliastro malato e depresso, geneticamente tarato”, non solo, secondo Guerri, forse, già a Torino si erano pentiti: “chi ce l'ha fatto fare?”.
Lo storico è convinto che ancora molto bisogna fare per far conoscere la vera storia del Risorgimento italiano, anche per Guerri è necessaria una “profonda opera di revisione storiografica”, specialmente sul brigantaggio. Pertanto scrive Guerri: “come ogni guerra civile, anche quella tra piemontesi e briganti è stata raccontata dal vincitore. Che però, a differenza del solito, non ha potuto vantarsene: si preferì nascondere o addirittura distruggere i documenti, perchè non fossero accessibili neppure agli storici”. Il brigantaggio postunitario, per la nostra storia fu “quasi un incubo da rimuovere o censurare, una pagina vuota, una tragedia senza narrazione.I briganti scontano, oltre alla sconfitta, anche il destino della dannatio memoria. A loro, non spetta l'onore delle armi”. Per i padri della patria rappresenta una specie di zona d'ombra, “una guerra in-civile come quella andava dimenticata, rimossa o almeno ridimensionata alla stregua di una semplice, per quanto sanguinaria, operazione di polizia”.
Ironicamente Guerri scrive che per i vincitori,“le pagine luminose, da consegnare agli archivi della memoria, sono altre: con tricolori sventolanti, imprese da trasmettere alle future generazioni nei manuali di scuola[...]”. Tuttavia lo storico senese auspicava che per le imminenti celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità nazionale, si rinunciava al“conformismo retorico e patriottardo”, alle“tentazioni oleografiche”, non tanto per “denigrare il Risorgimento, bensì di metterlo in una luce obiettiva, per recuperarlo – vero e intero – nella coscienza degli italiani di oggi e di domani[...]”. Nello stesso tempo però dall'altra parte si doveva rinunciare alle “ossessioni separatiste o secessionistiche che di tanto in tanto si trasferiscono dal Sud al Nord e ritorno”. Infatti, riferendosi a quest'ultimi, Giordano Bruno Guerri, sottolinea con forza, nell'introduzione al suo libro che “conoscere e rivedere il Risorgimento non significherà rimpiangere Radetzky o Francesco II, a seconda che il nostalgico si trovi a Milano o a Palermo”.
Da quello che ho visto e letto nel 2011, non mi sembra che sia andata così, sia per i risorgimentisti duri e puri, che per i nostalgici dei borboni. Forse gli unici a mantenere un certo equilibrio e non scadere in leggende nere o rosa sono stati quelli di Alleanza Cattolica, che sensibili agli avvenimenti storici del nostro paese, hanno voluto ricordare il 150° dell'unità d'Italia con una serie di conferenze all'insegna dello slogan: “1861-2011”. Unità Si, Risorgimento No”. Sostanzialmente si rifiuta l'ideologia risorgimentale che ha cercato di cancellare l'identità del nostro Paese, ma si accetta l'unità politica.
A questo proposito invito la lettura del “manifesto-appello”, che si può trovare nel sito, www.alleanzacattolica.org”.
“Il Sangue del Sud”, è composto di 17 capitoli. L'autore tratta in particolare la guerra del nuovo Regno d'Italia contro il brigantaggio, anche se troviamo delle pagine che raccontano le vicende della conquista del Regno delle Due Sicilie, come si sono comportati i vari protagonisti di questa conquista.
Guerri è abbastanza super partes, riconosce per esempio che i giovani sovrani, napoletani, Francesco II e Maria Sofia sono stati derubati del loro legittimo regno. Ricorda tutti i vari tradimenti dei nobili e dei generali borbonici, che hanno fatto a gara per abbandonare la “nave”, il prima possibile. Evidenzia un certo “gattopardismo”, nel sistema politico meridionale. Riconosce inoltre una certa stabilità e prosperità economica del regno napoletano, anche se evidenzia delle deficienze nello Stato meridionale. Certamente lo storico non si presta a una “leggenda aurea”, rappresentando un Regno di Napoli come il bengodi d'Europa.
Guerri, entra nel vivo del brigantaggio a partire dal VI capitolo:“Come nasce una guerra civile”. Anche Guerri come lo studioso cattolico, Francesco Pappalardo, è consapevole che il fenomeno del banditismo è sempre esistito. Ma il brigantaggio un'altra cosa, anche se ci sono elementi banditeschi. Si contano almeno 216 bande, tra Abruzzo, Molise, Sannio, entroterra irpino, nel salernitano, Puglia e Calabria. Le campagne erano una polveriera, bastava la presenza di qualche brigante, di qualche manutengolo, che iniziava la repressione, con saccheggi e incendi. “A farne le spese furono spesso uomini e donne inermi, messi al muro per aver gridato 'Viva Francesco II' in qualche stamberga dai muri troppo sottili, cafoni che si erano limitati a dare da mangiare ai ribelli, contadini e galantuomini che avevano abbracciato da subito la fede liberale”. Bisogna scrivere che soltanto la regina Maria Sofia, era abbastanza attiva nel sostenere la resistenza del popolo meridionale, mentre Francesco II, chiuso nello sconforto e nel fatalismo, faceva ben poco. Mentre i vertici della Chiesa ufficialmente non appoggiavano il brigantaggio, qualche vescovo e soprattutto i preti e i religiosi si sono resi complici.
L'esercito italiano arrivò ad impiegare al sud, fino a 120 mila uomini, quasi la metà dell'intero esercito unitario. Secondo Franco Molfese, tra il 1861 e il 1865 sarebbero stati uccisi, negli scontri o con le esecuzioni, 5212 briganti. Mentre Carlo Alianello, ne conta quasi il doppio (9860). “In entrambi i casi, si tratta di cifre approssimate per difetto”. Stessa cosa per i caduti da parte dell'esercito, qui spesso si taceva per non allarmare l'opinione pubblica, perchè la gente non doveva scoprire che si stava combattendo una vera e propria guerra. “Morirono più militari che nella somma delle tre guerre di Indipendenza, almeno 8.000”.
Mentre cronisti e storici locali contano oltre 100.000 caduti fra i meridionali. “Cifre a parte, - scrive Guerri - il dato oggettivo non cambia: fu combattuta una guerra civile, con rappresaglie, saccheggi e fucilazioni sommarie. E' il lato terribile di ogni contrapposizione fratricida”. Per Guerri, “quella conquista comportò episodi da sterminio di massa”.
Nei capitoli successivi lo storico toscano si occupa entrando anche nei particolari delle gesta più o meno eroiche dei vari briganti. Tra quelli più conosciuti, Carmine Donatelli, detto Crocco è quello a cui si dedica più spazio, del resto fu definito il re dei briganti. Poi c'è Chiavone, il brigante che voleva essere Garibaldi e marciare su Torino. Il sergente Domenico Romano, che univa il fucile alla preghiera. Un impasto di spirito crociato e di devozione religiosa, come si può leggere nel giuramento, che imponeva ai nuovi adepti. Un capitolo particolare e suggestivo viene dedicato alle brigantesse, tema che sarà poi sviluppato ampiamente nel successivo libro, “Il Bosco nel cuore”. E' un argomento che ha attirato la curiosità di molti studiosi. Alcuni li consideravano delle sanguinarie, delle diaboliche messaline. “Naturalmente si trattava di esagerazioni - con un fondo di verità – a sostegno dell'immaginario collettivo”.
Il Guerri sottolinea come la presenza femminile “sia molto più numerosa nella storia violenta del brigantaggio che in quella romantica del Risorgimento: dove – oltre alla contessa di Castiglione, per i suoi meriti spionistici e amatori – l'unica eroina è Anita Garibaldi, sposa esemplare”.
Queste donne secondo Guerri,“sono partigiane ante litteram; o, in un salto temporale ancora più lungo, sono le antesignane di un femminismo istintivo e rabbioso, ribelli stanche di essere confinate – da sempre – al letto, al focolare e ai figli”. E qui emerge lo spirito anarcoide di Giordano Bruno Guerri.
Comunque sia queste donne, “sono certe di trovare tra i boschi la dignità e la considerazione che non avrebbero ottenuto vivendo da schiave o puttane di nobili e galantuomini”. Pertanto, “la loro fuga è al tempo stesso un viaggio verso la libertà e verso la fine”. Sono un esercito di nomi e di storie senza volto, un'escrescenza della storia, per decenni considerata ingiustamente marginale. Giuseppina Vitale, Chiara Di Nardo, Rosaria Rotunno, Mariannina Corfù, Maria Pelosi, Filomena di Pote, Maria Maddalena De Lellis, Filomena Pennacchio, Michelina De Cesare, Maria Oliverio. Solo alcuni nomi di donne“che capovolgono pregiudizi e luoghi comuni su sesso debole”. Donne che “nascondono le chiome fluenti sotto le larghe falde di cappellacci maschili, occultano ciò che resta della loro femminilità con l'audacia”. Un altro dato che va sottolineato che si tratta per la maggior parte di ragazze abbastanza giovane, pronte a tutto, rispetto alle ragazze di oggi.
Finora era stato dedicato poco spazio al tema delle brigantesse, il lavoro ben documentato di Giordano Bruno Guerri colma questa lacuna. “Il Bosco nel cuore” , è la storia delle donne in guerra contro l'unità; la storia di madri, mogli, ragazze giovanissime, rivendicare il diritto di vivere la propria vita assumendo su di sé il potere e la libertà di decidere.


.jpeg)

.jpeg)










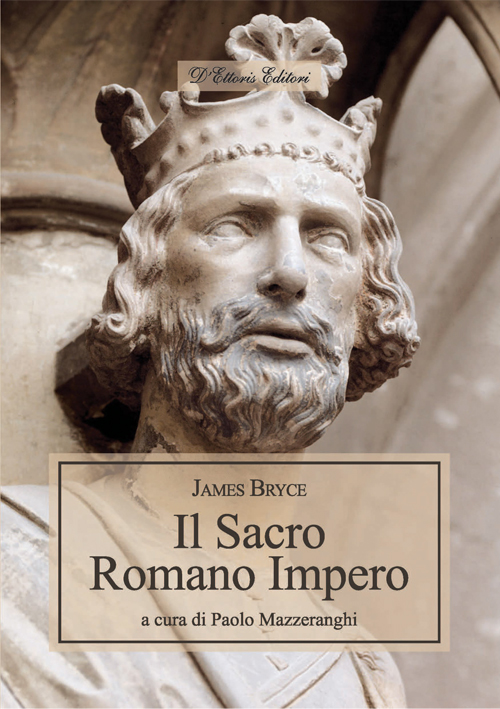








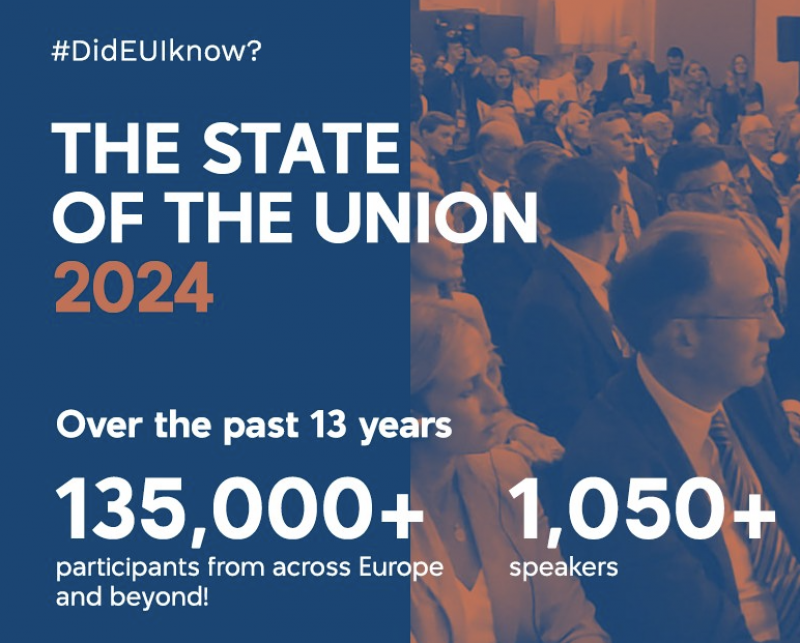





































)
































.jpg)
.jpg)
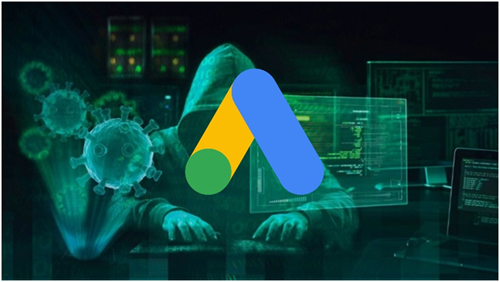


























.jpg)



















.jpg)


.png)


